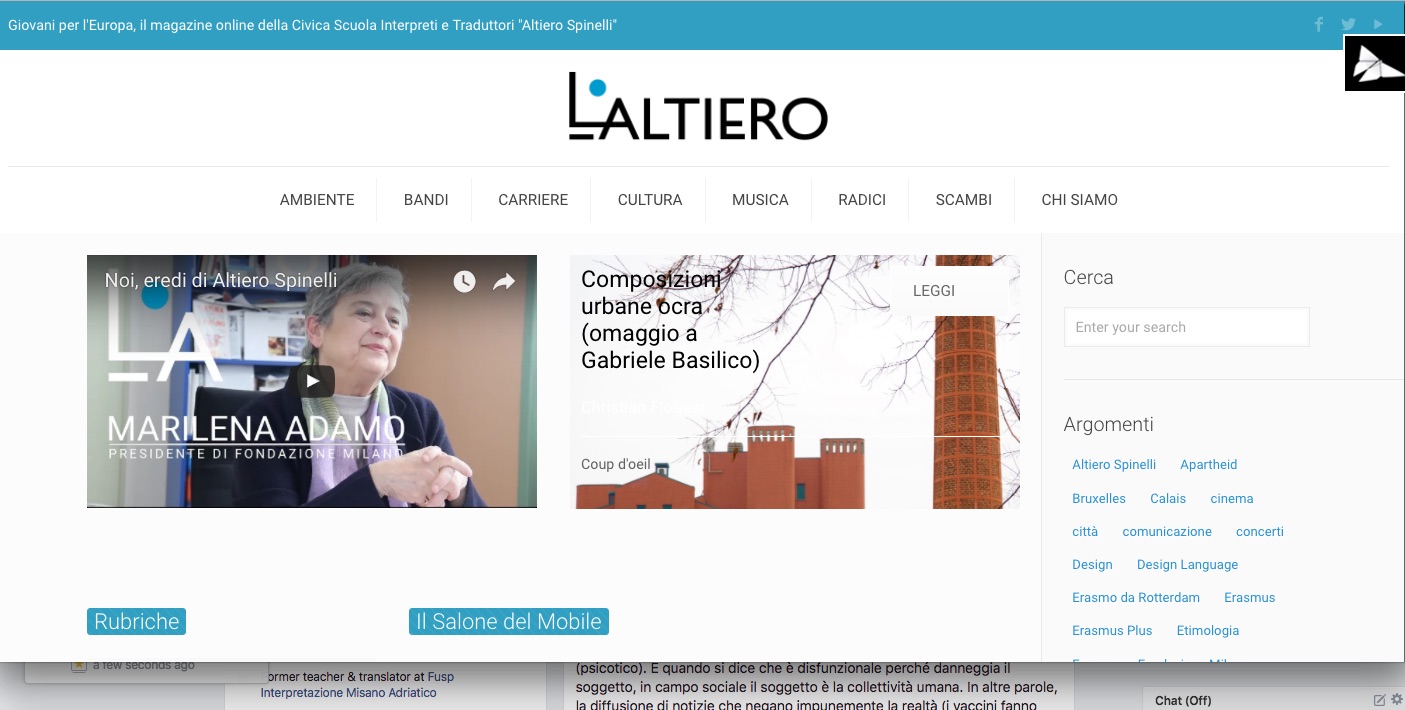Qual è il ruolo della traduzione nella cultura italiana? Perché nella nostra cultura manca una definizione ben precisa della traduzione? Quali ricadute ha la mancanza di una specifica categoria culturale della traduzione sul panorama professionale della traduzione in Italia? A queste e altre domande ha risposto il traduttologo Bruno Osimo. Osimo è docente di scienza della traduzione, traduzione dal russo, traduzione dall’inglese e coordinatore del corso di Mediazione Linguistica alla Civica scuola interpreti e traduttori «Altiero Spinelli» di Milano.
Dottor Osimo, lei sostiene che sapere le lingue e saper tradurre non siano la stessa cosa e che nella cultura italiana manchi la categoria culturale della traduzione. Cosa intende esattamente?
Sono convinto che nella cultura italiana non si riconosca lo specifico della traduzione. Io, ad esempio, ai miei tempi ho studiato lingue e non traduzione. Il corso di laurea era quello di Lingue e Letterature Moderne ed era tutto quello che c’era per poter diventare traduttori. Oggi però noi sappiamo che sapere le lingue e saper tradurre si esercitano con capacità diverse e che anche a livello cognitivo si tratta di due cose diverse, che culturalmente hanno due fini diversi. Sapere le lingue serve per molte professioni, quasi per tutte quelle moderne. Medici e ingegneri, ad esempio, non possono non sapere l’inglese. Queste figure professionali, tuttavia, possono benissimo non saper tradurre. Un traduttore, invece, deve essere soprattutto un mediatore. Le capacità che richiede la mediazione sono più affini a quelle di un mediatore culturale o di una persona che deve mediare tra due persone. Pensiamo al terapeuta della coppia. Questo deve sapersi immedesimare nella cultura individuale di ciascuno dei due membri per poter fare da mediatore. Poi però deve arrivare a una sintesi che esprima una cultura terza che non sia nessuna delle culture dei due. Questa cultura terza in gergo tecnico si definisce linguaggio d’intermediazione tra il linguaggio di uno e quello dell’altro. Questo linguaggio di intermediazione deve poter esprimere tutto quello che vogliono dire la persona A e la persona B della coppia nei rispettivi linguaggi. Però deve esprimerli in un linguaggio C che sia comprensibile sia per A che per B. La stessa cosa succede con la traduzione sia scritta che orale. Il linguaggio d’intermediazione, nel caso della traduzione, è un linguaggio e non una lingua.
Lei afferma che in Italia la traduzione ancora non abbia una sua definizione specifica ben precisa. Ci sono altri paesi in cui invece questa è ben chiara e definita?
Se utilizziamo i settori disciplinari dell’università italiana come parametro obiettivo, possiamo notare che non esiste un settore disciplinare dedicato alla traduzione. La traduzione è sparpagliata un po’ ovunque tra lingua, letteratura e didattica della lingua. Se poi pensiamo alle associazioni di categoria, credo che la coscienza professionale di traduttori e interpreti in Italia sia tra le più basse del mondo occidentale. Non sono favorevole alle corporazioni, ma segnalo che l’autocoscienza dell’essere traduttori è un sintomo di qualcos’altro. Se lei va in Svizzera, ad esempio, trova tariffe per traduttori anche di cinque volte più alte. In questo paese i traduttori godono di un riconoscimento sociale e intellettuale di alto livello.
Più o meno lo stesso problema degli insegnanti della scuola dell’obbligo.
Sicuramente c’è qualcosa in comune. La cultura italiana assegna un ruolo simile ad entrambe le figure professionali. Ma questo è un problema di ignoranza. Per insegnare nella scuola dell’obbligo ci vogliono grosso modo tutte le capacità che servono per insegnare all’università. Non è che sia più facile, anzi.
Lo scarso riconoscimento per i traduttori dipende anche dalla scarsità di percorsi di formazione specifici per la traduzione?
I traduttori stessi hanno le loro responsabilità. Non si riesce ancora a dare della traduzione un’immagine professionale. Molto spesso ci si improvvisa traduttori. Molti lo fanno per tappare dei buchi nella loro esistenza.
Adesso poi ci sono Internet, nuove tecnologie, i traduttori automatici, i sottotitolatori amatoriali. Veri e propri fenomeni di traduzione di massa a basso costo o addirittura gratuita.
Su questo faccio sempre l’esempio del vino. Quando io ero piccolo se dovevo comprare del buon vino per la mia famiglia dovevo andare dal contadino perché al supermercato c’erano solo le marche scadenti. Adesso se andiamo al supermercato si possono anche trovare vini buoni. Questo significa che negli ultimi cinquant’anni i produttori hanno fatto un buon lavoro per far capire che il vino può essere un prodotto buono o cattivo. Con la traduzione questo non è ancora stato fatto. Ci vorrebbe un processo culturale simile per la traduzione. Un’operazione di marketing per far capire che la traduzione che puoi avere a due euro non è la stessa che puoi avere a venti euro. Quello che sta succedendo a me e anche ad altri colleghi miei coetanei è che lavoriamo sempre meno e che molto spesso il lavoro viene assegnato a principianti molto più “cheap”. Cosa che di per sé è anche bella. Il punto è che il lavoro dei professionisti con più esperienza può e deve convivere con quello di chi entra a lavorare in questo settore. Ci potrebbero essere due fasce di prezzo, quella del neolaureato e quella di chi magari ha tradotto per trent’anni i classici della letteratura, come c’è il vino in tetrapack e il Brunello di Montalcino.
Per quanto riguarda le nuove tecnologie, la traduzione automatica è stata rimpiazzata dalle memorie di traduzione. Tale tecnologia concettualmente non si basa più sulla linguistica lessicale ma sulla semiotica – a sua insaputa, credo. Le memorie di traduzione si basano su stringhe di testo, e dunque sul contesto, anziché sulle singole parole. Le memorie sono utili, lo ripeto, non per sostituire i traduttori ma per aiutarli. Bisognerebbe che i traduttori fossero mentalmente un po’ più elastici e, purtroppo, non sempre è cosi. Soprattutto i traduttori letterari, che io preferisco chiamare traduttori artistici, non devono vedere la tecnologia come fumo negli occhi. Anche nel campo della traduzione artistica le memorie di traduzione possono essere di grande aiuto.
Può farci in esempio.
Penso alle ripetizioni e alla ricerca esasperata di sinonimi. In questo senso siamo tutti un po’ vittime di Cicerone dopo tutti questi millenni. Pensiamo ancora alla ripetizione come a una cosa negativa. Io credo che se Čehov ripete dieci volte una parola nello stesso racconto lo debba aver fatto a ragion veduta.
Passiamo agli aspetti teorici della sua ricerca sulla traduzione. Lei sostiene che il traduttore sia una sorta di antropologo, può spiegarci meglio?
Se noi abbandoniamo l’idea che la traduzione sia una questione di lingua ed entriamo nell’idea che sia un problema di cultura, entriamo di fatto nel dominio dell’antropologia. In semiotica il concetto di testo quasi coincide con quello di cultura e viceversa. Quando noi affrontiamo un testo affrontiamo una cultura e dobbiamo interpretarla. Anche la strategia traduttiva diventa un tipo di atteggiamento culturale come potrebbe essere quello sciovinista oppure quello multiculturale. I traduttori sono nel contempo protagonisti e sensori dei rapporti tra culture. Il traduttore diventa così non più uno che trasporta, ma uno che crea un linguaggio nuovo ogni volta che traduce un testo nuovo.
Quest’idea si applica solo alla traduzione artistica o anche a quella tecnica e a tutti i tipi di traduzione?
Vale per tutti i tipi di traduzione. Anche se devo tradurre un manuale tecnico mi rivolgo a un lettore modello e ho una dominante. Anche il traduttore artistico è un traduttore tecnico-settoriale. Tra l’altro ci sono molti studiosi dell’Est europeo che hanno dimostrato scientificamente che non c’è nessun motivo di principio per distinguere la traduzione letteraria da quella non letteraria. La cultura e la lingua non sono estricabili l’una dall’altra, per questo preferisco utilizzare il concetto di Agar di “linguacultura”. Questa va vista come un organismo vivente e non come un oggetto. E il testo va visto come un processo.
In questo caso sarebbe la traduzione a inglobare la linguistica e non viceversa.
Dal punto di vista della semiotica è così, la linguistica fa parte della semiotica e non viceversa. La traduzione non so, forse questa potrebbe avere un ruolo più forte nella semiotica. Va di moda oggi usare il concetto di traduzione con cose che con la traduzione non hanno nulla a che vedere. La semantica può certamente fare riferimento alla traduzione per molti dei suoi principi. Adesso molti convergono nel cercare i significati nella traduzione. Se tu vuoi sapere cos’è veramente sedia traduci sedia in un’altra lingua. Quello che resta invariato è il significato di sedia. Quando non riusciamo a tradurre bene qualcosa dobbiamo ricorrere al pensiero creativo, che è l’unico strumento che ci permette di superare i momenti di intraducibilità. Le traduzioni possono essere ad alto tasso di traduzionalità o a basso tasso di traduzionalità. Il pensiero creativo è particolarmente utile con il primo tipo di traduzioni.
Lei sostiene che una nota del traduttore non sia una sconfitta.
Le note del traduttore non nascondono il fatto che una traduzione sia tale e il lettore in genere non è stupido e quando legge un testo tradotto sa che non si tratta dell’originale. Se diamo fiducia a questo tipo di lettore modello, le note del traduttore sono strumenti per “assaggiare“ la cultura in cui nasce l’originale. Un abuso di queste note, tuttavia, testimonia a mio avviso una velleità sbagliata del traduttore di far avvertire la propria presenza. Le note del traduttore sono però antropologicamente utilissime.
In conclusione, quanto di originale c’è nella sua ricerca e quanto viene da altri linguisti o esperti della traduzione?
Premetto che nella formulazione della mia ricerca mi avvalgo di contributi di illustri semiotici come Lotman e Peirce. Di originale nella mia ricerca c’è il fatto che io utilizzo i contributi teorici di questi semiotici per sviluppare un’idea della traduzione che in quanto tale è originale. Per quanto riguarda l’antropologia, mi sono avvalso del contributo teorico di Agar. Egli ha utilizzato il concetto di traduzione per spiegare ai suoi colleghi cos’è la cultura. Io, invece, ho provato a fare il reciproco. Vorrei ricordare che sia su Lotman che su Jakobson, del cui contributo pure mi sono avvalso, ho scritto due libri in corso di pubblicazione. I due testi si intitolano “Manuale di traduzione di Roman Jakobson”, pubblicato in italiano da Blonk, e “Il manuale del traduttore di Jurij Lotman”, che uscirà in inglese da Tartu University Press e in italiano da Marcos y Marcos.
La ringrazio per l’intervista, a presto.
Grazie a lei per l’originalità delle domande.
A risentirci.
© Informalingua
Nato a Milano nel 1958, scrittore e teorico della traduzione, Bruno Osimo è docente di scienza della traduzione, traduzione dal russo, traduzione dall’inglese e coordinatore del corso di Mediazione Linguistica alla Civica scuola interpreti e traduttori «Altiero Spinelli» di Milano. Svolge ricerche nel campo della traduzione.