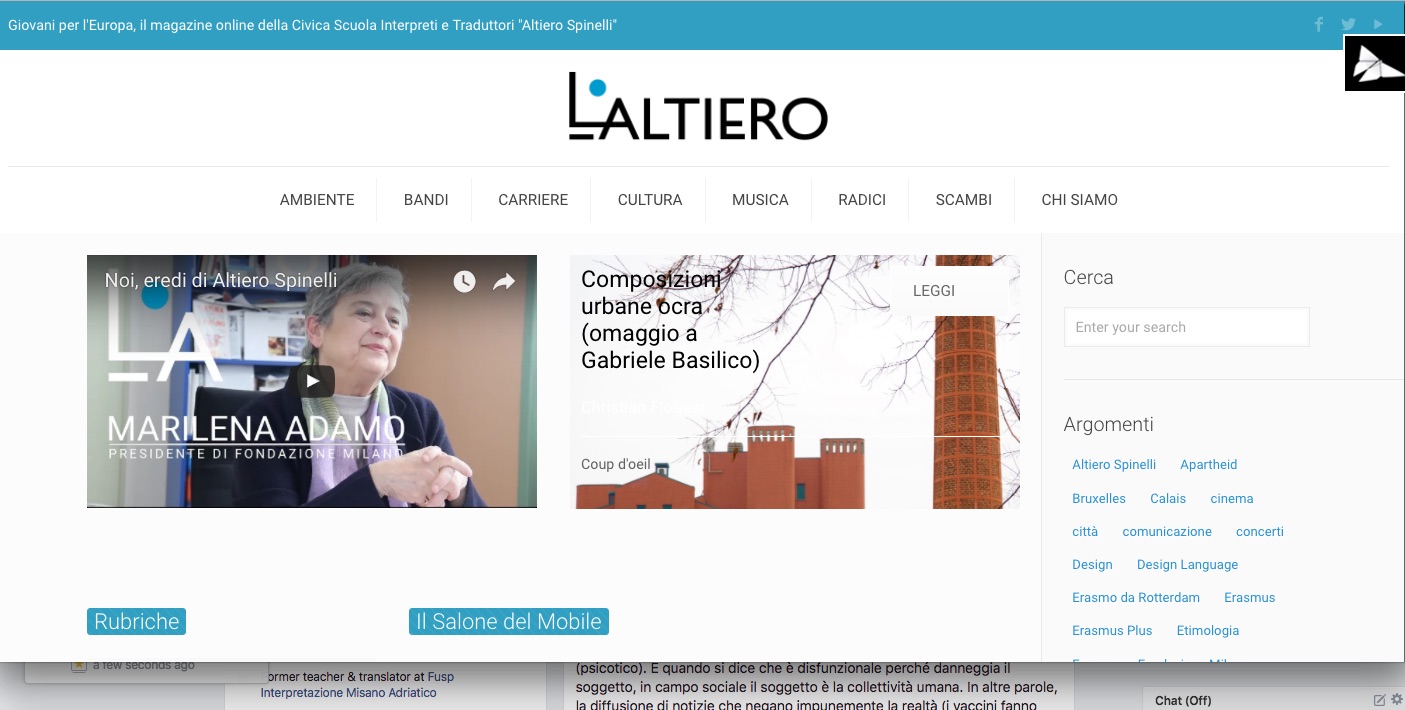https://giacomoverri.wordpress.com/2016/12/16/dire-quasi-la-stessa-cosa-bruno-osimo-e-anton-pavlovic-cehov/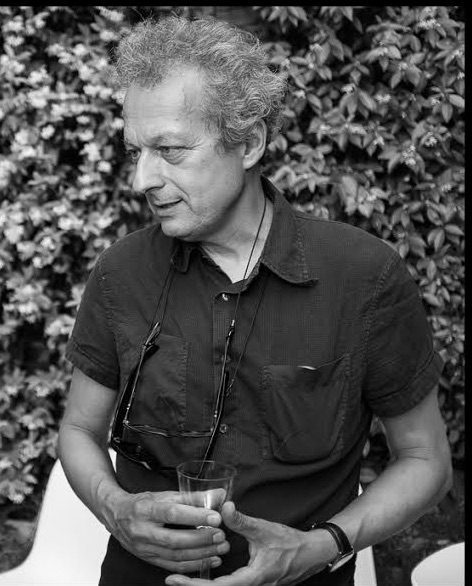
«Io parto», disse. «Ivàn Andréič rimanga pure, ma io parto».
«Dove andate»?
«In Russia».
«Ma là di che cosa vivrete? Voi non avete nulla».
«Farò traduzioni oppure… oppure aprirò una bibliotechina…»
Le scadenze di consegna dei cinque oscar Mondadori dedicati ai racconti di Čehov – organizzati in stretto ordine cronologico – si snodavano tra il settembre del 1994 e il giugno del 1995. Fatalità, anche questo numero finisce per cinque, un po’ come il quinto giorno della settimana, venerdì, per Laévskij, personaggio che nel Duello non vede l’ora di partire per togliersi dalle croste la donna con cui vive, che – in questo momento – trova insopportabile. Nella traduzione mi sono dovuto arrampicare sui vetri per far capire anche al lettore italiano che a un certo punto il numero cinque, che viene evocato dai voti della pagella di una bambina molto studiosa (il cinque è il voto massimo), a Laévskij fa venire in mente il venerdì:
Anche Laévskij guardò i voti e li elogiò. Catechismo, lingua russa, condotta, i cinque e i quattro gli balzavano davanti agli occhi, e tutto ciò insieme al giorno cinque che lo perseguitava, al riporto sulle tempie di Nikodìm Aleksàndryč e alle guance rosse di Kàtja gli sembrò una noia talmente immensa, invincibile, che per poco non si mise a gridare dalla disperazione e non si domandò: «Possibile, possibile che io finisca per non partire?»
Il cinque a Laévskij fa venire in mente il quinto giorno della settimana, il cui nome in russo ha la stessa radice di pât’, «cinque». E così – prendendo in prestito l’idea in parte anche dall’ebraico (dove però venerdì è il giorno sei) – ho trasformato un «venerdì» in un «giorno cinque». Mi è sembrato non troppo grave, se il lettore penserà al quinto giorno del mese anziché della settimana:
Le parole «il giorno cinque» per qualche motivo non gli andavano via di testa; non pensava a nulla, tranne che al giorno cinque, e per lui era evidente soltanto, però non nella testa, ma in un punto sotto il cuore, che sabato non era il caso di partire.
Io non c’entravo nulla con la scelta editoriale dei racconti: il progetto era di Igor Sibaldi, il curatore, e della redazione degli Oscar classici. All’epoca ero traduttore a tempo più che pieno, con due bambini piccoli e poche risorse economiche, traducevo di tutto, da Comunità virtuali di Rheingold a C’era una volta una guerra di Steinbeck, da La rivoluzione positiva di De Bono al Dizionario di psicoanalisi dell’associazione psicoanalitica statunitense. Nell’impresa čehoviana ero la manodopera salariata incaricata di tradurre, e mi era stato fornito un elenco con i titoli dei racconti da “fare” volume per volume (non i testi, ché tanto li avevo già a casa nella prestigiosa edizione dell’Accademia delle scienze). Perché li avevo? Forse, come Laévskij, per tentare di salvarmi dalla volgarità e dalla vanità della vita.
Due anni prima, quando si era innamorato di Nadéžda Fëdorovna, gli sembrava che sarebbe bastato mettersi con Nadéžda Fëdorovna e partire per il Caucaso con lei per salvarsi dalla volgarità e dalla vanità della vita.
Salvarsi dalla volgarità. Per Antón Pàvlovič, il motto di una vita. Da parte mia, a sedic’anni per il momento stavo solo cercando di imparare una lingua, a quanto mi sembrava, esotica, col suo alfabeto così strano, «quasi uguale a quello ebraico» avrebbe detto mia madre. Negli ultimi due anni di liceo, tra il 1975 e il 1977, avevo bazzicato l’Associazione per i rapporti culturali con l’Unione sovietica di via Dogana 4 a Milano, dove ero stato inserito nel gruppo della professoressa Maria Giulia Carrara, unica docente non di madrelingua russa della prestigiosa scuola. E con lei avevamo studiato tutta la grammatica (tutta) sul sovieticissimo – ma rilegato con “borghese” dorso rigido – manuale in russo della Pul’kina, tanto che poi nel 1978, al seminario di Villa Feltrinelli a Gargnano nel giugno del primo anno di letteratura russa alla Statale, il capo dell’istituto di russo Eridano Bazzarelli, innamorato perso del grande poeta Blok al punto di insegnarlo ininterrottamente per vari decenni, anziché lasciarmi nel bellissimo cortile-con-annesso-molo insieme alle altre matricole che leggevano – in italiano – i Drammi lirici tradotti da Sergio Leone e Sergio Pescatori nell’edizione Einaudi, mi metteva coi “grandi” del terzo e del quarto anno al piano disopra, in biblioteca, a leggere in originale le poesie di Blok e Roza i krest. Memore della fatica che facevo allora anch’io a indovinare la vocale su cui si posava l’accento, in italiano quando posso lo segno sempre, perché credo che una maggiore sicurezza da parte del lettore non russista nel leggere i nomi russi in modo corretto porterebbe a una confidenza migliore con tutta la cultura russa:
Un cinquecento passi dopo il duhàn, le carrozze si fermarono. Samójlenko aveva scelto un praticello su cui erano disposte rocce comode per sedersi e dove giaceva un albero abbattuto dalla bufera, con le radici pelose dissotterrate e gli aghi gialli secchi. Qui sul fiume era stato posato un instabile ponte di legno, e sull’altra riva, proprio di fronte, su quattro bassi montanti c’era un piccolo capanno, un essiccatoio per il mais che ricordava l’izbà sulle zampe di gallina delle fiabe; dalla porta scendeva una scaletta.
L’izbà (ebbene sì, non si chiama ìsba) sulle zampe di gallina tipica delle fiabe russe è una specie di palafitta, ma siccome ci abita la baba âgà, una strega cattiva, i pali sono orribili, come zampe di gallina giganti, appunto.
Magari anch’io ero un elemento poco affidabile, con zampe di gallina, in quanto proveniente dalla scuola interpreti – che volgarità, così lontana dai sacrari dove si distillava la Cultura Accademica! Per fortuna non sapevo che tra questi “grandi” del Gotha dei russisti della Statale, su in biblioteca, a cui ero stato ammesso con riserva e in via del tutto provvisoria e solo in quanto “tecnico della lingua” («Chiama Osimo che c’è un guasto alla lingua!») c’erano anche Igor Sibaldi (diciassette anni dopo curatore di questi racconti) e Monica Gattini (trentasette anni dopo – oggi – direttrice generale della Fondazione Milano di cui fa parte la Civica scuola interpreti e traduttori «Altiero Spinelli» in cui insegno oggi). Già così, ero abbastanza intimidito.
«Non capisco per che diavolo io stia venendo con voi», disse Laévskij. «Quant’è sciocco e volgare! Ho bisogno di partire per il nord, di fuggire, di salvarmi, e chissà perché invece vengo a questo stupido picnic».
Le prospettive col tempo cambiano. Bazzarelli quell’anno aveva l’esatta età mia di oggi, e a me sembrava un vecchietto. Io, invece, ero un giovane uomo, ma mi sentivo un bambino. E non capivo perché stessi andando allo “stupido picnic” della traduzione professionale. Era una scelta o un modo per non scegliere? Era una vera professione o un passatempo per casalinghe di buona famiglia annoiate? E io, ero una casalinga? Ed ero annoiata? Era una vocazione, o un espediente per non dover uscire mai di casa e non salutare nessuno, salvando le apparenze?
«E così…» continuò. «Voi studiate sempre, raggiungete il fondo del mare, distinguete i deboli dai forti, scrivete libri e sfidate a duelli – e tutto rimane al suo posto, invece in un batter d’occhio basta che uno stàrec debole blateri con spirito santo una sola parola, о dall’Arabia arrivi al galoppo un nuovo Maometto con la sciabola, e tutto viene messo sottosopra, e in Europa non resta pietra su pietra».
Nel 1977, “costretto” dalla frequenza al corso a farmi socio dell’Associazione Italia-Urss, ricevevo le offerte promozionali sovietiche su volantini prodotti – immagino – con un ciclostile del 1917 o giù di lì, e, quando vi ho letto che stavano uscendo le opere complete di Čehov in diciotto volumi, non ho resistito e le ho ordinate, per motivi legati più al design che alla reale voglia di leggerli. E così, alla convocazione sibaldo-mondadoriana, dopo avere preso polvere sullo scaffale diciassette anni, finalmente stavano tornando utili. Senza saperlo, non leggendoli avevo quasi messo in pratica il consiglio di un personaggio del Duello in quella che sembra quasi una notazione lotmaniana sull’intraducibilità tra linguaggi continui e linguaggi discreti:
«A che scopo?» domandò Laévskij. «L’impressione è meglio di qualsiasi descrizione. Di questa ricchezza di tinte e suoni, che ognuno riceve dalla natura tramite le impressioni, gli scrittori imbastiscono un blablà deforme, irriconoscibile».
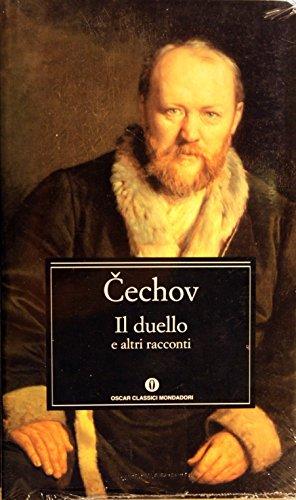
E probabilmente anche i traduttori imbastiscono qualcosa di simile. Le citazioni di cui è intriso questo mio testo sono, appunto, tratte dal Duello, che proprio un racconto magari non è, con le sue cento cartelle (duecentomila battute, 36.547 parole).
Scrivere in cielo col forcone non ha da essere né particolarmente raffinato, né particolarmente duraturo. Forse l’idea di tradurre come “lavoretto estivo” dell’epigrafe pensavate che fosse uscita in un numero di inizio estate 2016 del Corriere della sera, dove si danno consigli su come arrotondare per mettere via i soldi per le vacanze. E poi le associazioni di categoria scrivono lettere di vibrante protesta. Invece è soltanto il pensiero bacato di Nadéžda Fëdorovna, classe 1869, una delle protagoniste, quando medita di lasciare il proprio concubino Laévskij, il quale però è in cerca di uno stratagemma per lasciarla, convinto che lei gli si sia accozzata e non lo voglia più lasciar vivere.
L’aria che respiro è vino, amore, insomma, finora avevo comprato la vita al prezzo della menzogna, dell’ozio e della codardia. Finora avevo ingannato gli altri e me stesso, ne ho sofferto, e le mie sofferenze erano da poco prezzo e volgari.
Volgari. Il tema per eccellenza di Čehov. Nessuno può dire di sapere cosa sia davvero la volgarità, dove si annidi, se non ha capito Čehov. Sì perché noi tendiamo a pensare che sia la pornografia, o l’oscenità, o la scatologia, e poi Antón Pàvlovič ci fa capire che è molto più insidiosa, sta nei gesti quotidiani, nei gusti conformisti, nelle abitudini, nel fatto stesso di non riuscire a capire dove sta la volgarità e nel prendere posizione in campi dove si è del tutto ignoranti, diventando dei parvenudella sapienza. In quattordici anni che traducevo, non avevo mai incontrato un autore così affascinante e formativo, sia sul piano dello stile sia su quello dei contenuti. Darwinianamente, se tutto funzionasse a dovere, i parvenu verrebbero spazzati via dalla selezione naturale. La facilità di costumi, i rapporti sessuali fuori dal matrimonio, la capacità di emanare odori ormonalmente interessanti senza essere biologicamente selezionati, sono condannati, in chiave non morale, ma biologica.
Il fatto che le ragazze soffochino i figli illegittimi e vadano poi ai lavori forzati, e che Anna Karénina si sia buttata sotto un treno, e che nei villaggi spalmino la porta di pece, e che a me e te, chissà perché, piaccia di Kàtja la purezza, e che ognuno senta confusamente l’esigenza di un amore puro, pur sapendo che un amore simile non esiste – tutto questo è forse un pregiudizio? Questo, caro mio, è l’unica cosa che ci è rimasta dalla selezione naturale e, se non ci fosse questa forza oscura che regola le relazioni tra i sessi, i vari signori Laévskij te lo farebbero vedere, dove svernano i granchi, e nel giro di un paio d’anni l’umanità degenererebbe.
Speriamo che i vari signori Laévskij non ci facciano mai vedere dove svernano i granchi, dunque! Nel Duello lo zoologo Von Koren – forse un alter ego di Antón Pàvlovič stesso – ha una filosofia di vita in chiave biologica, nella quale meritano di sopravvivere solo gli individui fit. Sul palcoscenico dell’evoluzione non esiste la pietà, vige solo la legge del più utile e del più adatto, o adattato. Persino il falangio, temibile aracnide velenoso, svolge un ruolo prezioso nella selezione naturale:
«Non so di quale animaletto stia parlando», disse von Koren, «verosimilmente di un insettivoro. Beh, e allora? L’uccello gli è capitato a tiro perché è imprudente; ha distrutto il nido con le uova perché l’uccello non è abile, ha fatto male il nido e non è stato capace di mimetizzarlo. La rana, verosimilmente, ha un vizio nella pigmentazione, altrimenti lui non l’avrebbe vista, e così via. Il tuo animaletto distrugge solo i deboli, i meno abili, gli incauti – insomma gli esemplari che hanno difetti che la natura non considera necessario trasmettere ai posteri. Sopravvivono solo i più furbi, attenti, forti ed evoluti. In questo modo il tuo animaletto, senza sospettarlo nemmeno, contribuisce agli elevati obiettivi dell’evoluzione delle specie».
Io – che la penso all’incirca come von Koren sull’utilità delle persone, me compreso – mi sono innamorato di questa novella. Mi sembra che la concezione del mondo di Čehov vi si trovi racchiusa perfettamente. Concezione del mondo nelle grandi e nelle piccole cose. È stato Čehov a farmi capire, per esempio, che la precisione terminologica va perseguita anche nelle opere d’arte. Anche annoiarsi e dire sempre di no a tutto può essere volgare, specie quando l’unico argomento a risvegliare l’interesse è il sesso: in ciò Čehov ha bisogno dello zoologo von Koren per farsi dare una mano. La sua morale è zoologica.
Ha un’aria tormentata, delusa, per lui non c’è niente di interessante, è tutto volgare e insignificante, ma non appena ci si mette a parlare di animali maschi e animali femmine, per esempio di come la femmina del ragno dopo la fecondazione mangi il maschio, – gli occhi gli si accendono di curiosità, il viso gli si schiarisce e, in poche parole, rinasce.
Se si adotta il filtro zoologico di Čehov, tante questioni prendono una luce nuova. Per esempio, è stato Čehov a farmi capire che anche le persone molto capaci di scrivere e/o di tradurre sono operai che usano mattoni e cemento e intonaco e che non si vergognano affatto all’idea di avere a che fare con una professione – un mestiere – e col suo materiale.
«Non t’indispettire, ragiona invece», disse lo zoologo. «Beneficare il signor Laévskij secondo me è stolto quanto innaffiare un’erbaccia o nutrire una locusta».
Negli ambienti intellettuali – dove in mancanza di selezione naturale erbacce e locuste non mancano – generalmente si anela alla letteratura e si aborrisce la lingua, volgare materiale da costruzione (con cui ci si “sporcano” le mani).
Laévskij aveva l’abitudine, intanto che parlava, di esaminarsi con attenzione il palmo rosa della mano, di rosicchiarsi le unghie o di lisciarsi i polsini con le dita. Ed era proprio quello che stava facendo adesso.
Vantarsi di fare un mestiere intellettuale e provare ripugnanza per quelli materiali, pratici, costruttivi non è tipico degli artisti e dei geni, ma dei presuntuosi. Quello che suggerisce Čehov darebbe loro fastidio, lo considererebbero volgare:
Le scienze umane di cui parlate soddisfaranno il pensiero umano solo quando nel loro movimento incontreranno le scienze esatte e vi si affiancheranno. Se si incontreranno al microscopio, o nei monologhi di un nuovo Amleto, o in una religione nuova, non lo so, ma credo che prima che ciò accada la terra si coprirà di una crosta di ghiaccio. La più tenace e viva di tutte le conoscenze umanistiche è naturalmente l’insegnamento di Cristo, ma guardate come persino quello viene concepito in modo diverso! Alcuni predicano di amare il prossimo, e così dicendo fanno eccezione per i soldati, i delinquenti e i matti: ai primi danno il permesso di uccidere in guerra, i secondi li si può isolare o giustiziare, e ai terzi viene vietato sposarsi. Secondo altre interpretazioni s’insegna ad amare il prossimo senza eccezioni, senza distinguere vantaggi e svantaggi.
Anche nel campo della traduzione vediamo questo principio delle eccezioni all’opera quando alcuni traduttori artistici proclamano la necessità di una disciplina tutta per sé, che non contempli al suo interno i testi “tecnici” (per usare la parola con cui sono sgradevolmente definiti).
«Può darsi…» concordò Laévskij, che era troppo pigro per ragionare e controbattere. «D’altra parte», disse dopo un po’, «che cosa sono Romeo e Giulietta, in sostanza? Un amore bello, poetico, sacro – sono rose, sotto le quali si vuole nascondere il putrido. Romeo è un animale, come tutti».
Per alcuni colleghi, mezzo secolo di semiotica della traduzione – in apparenza – è passato invano. E, soprattutto, si fa fatica a riconoscere la settorialità, la specificità, la tecnicità di tutti i tipi di traduzione. È piuttosto evidente che la traduzione di un’opera d’arte è quanto di più “tecnico” si possa immaginare, data la cospicua quantità di conoscenze settoriali indispensabili per poterla realizzare.
«Pregiatevi di continuare a vivere e avere a che fare con signori di tal fatta!» disse lo zoologo e in segno di spregio calciò in un angolo un pezzo di carta. «Cerca di capire, che questa non è bontà, non è amore, ma codardia, depravazione, veleno! Quello che la ragione fa, lo distruggono i vostri cuori fiacchi, buoni a nulla! Quando al ginnasio mi sono ammalato di tifo addominale, mia zia per compassione mi nutriva a funghi marinati, e per poco non sono morto. Tu e mia zia dovete capire che l’amore per l’uomo deve trovarsi non nel cuore, non sotto lo sterno, non alla cintola, ma qui dentro!»
per l’intervista completa: