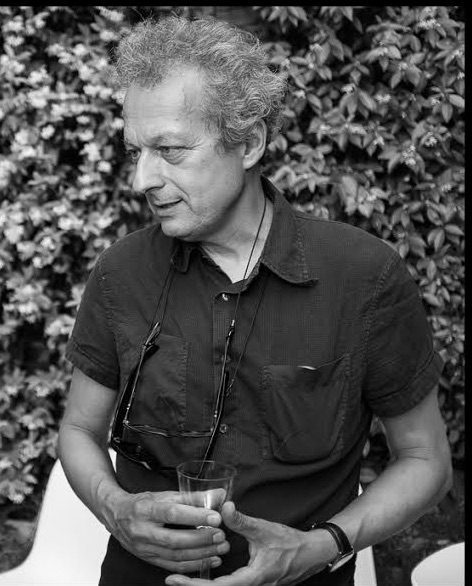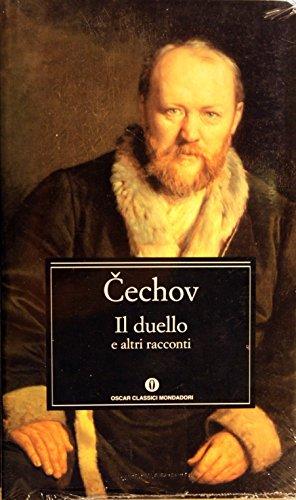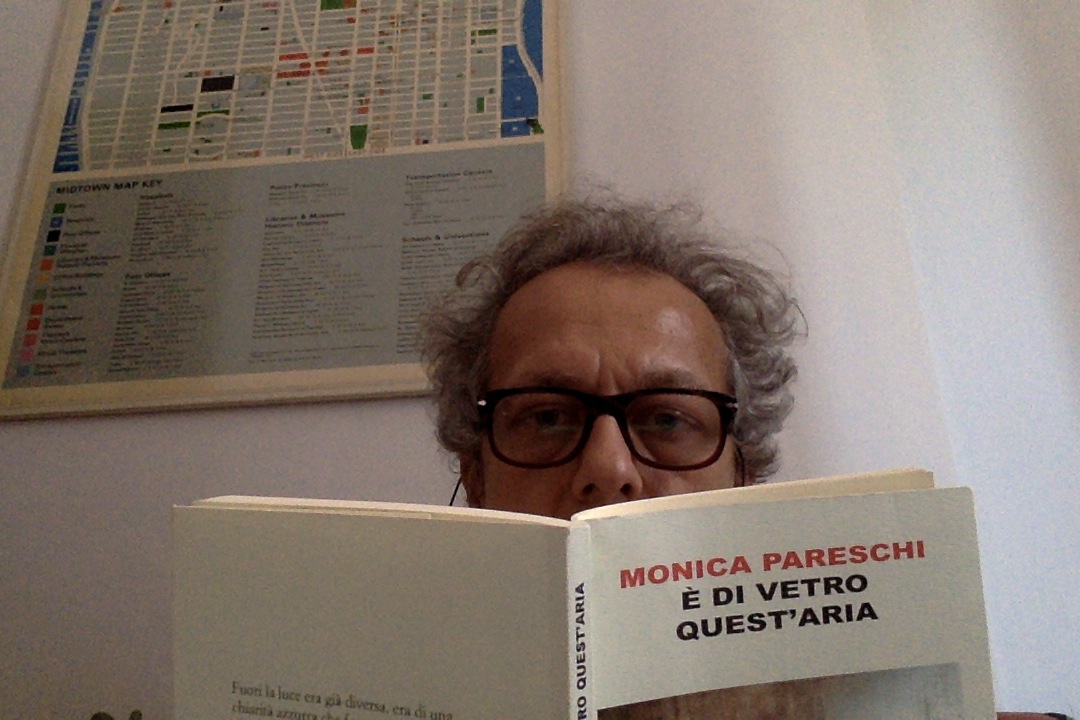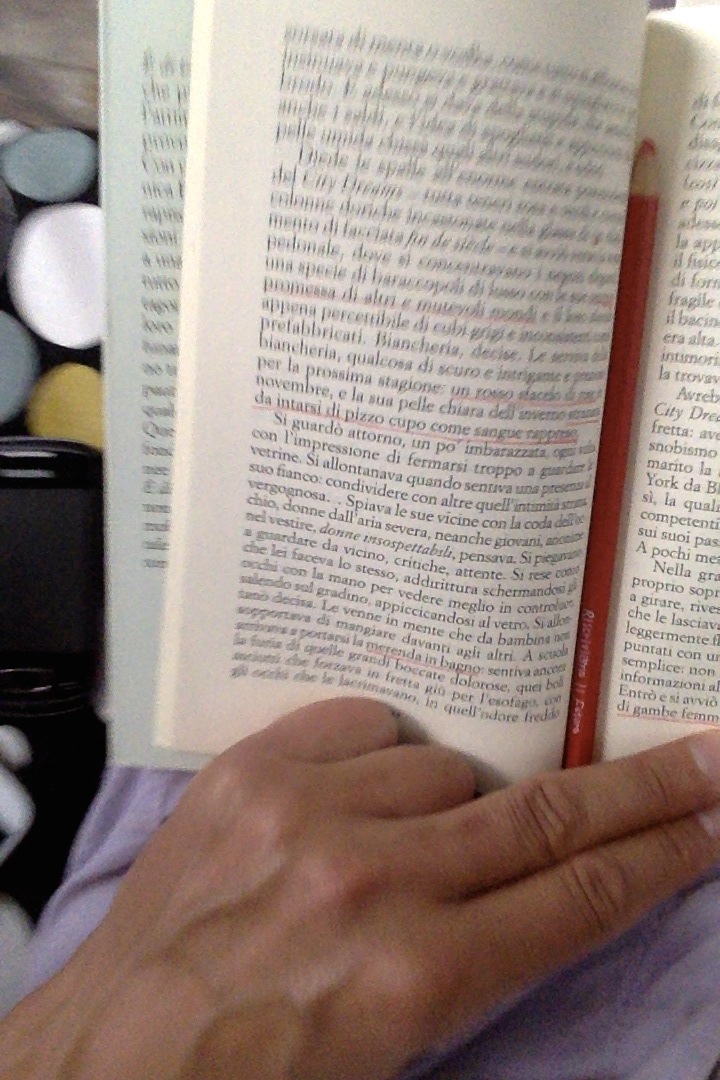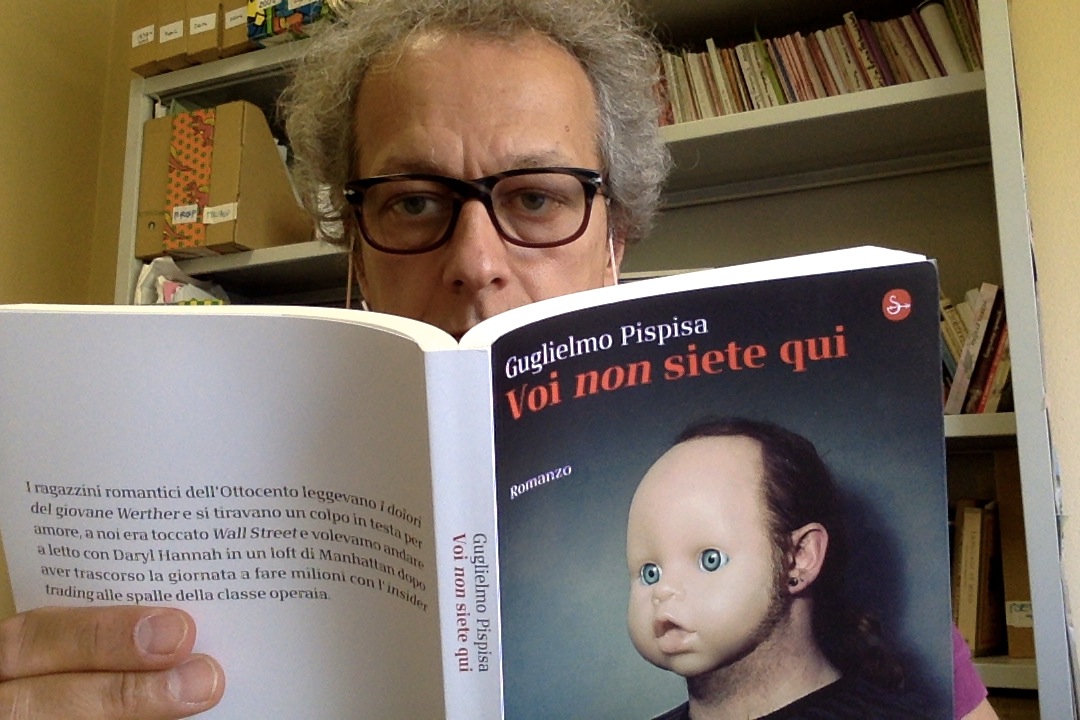Vladimir Nabókov: Candid Conversation
Intervista a Playboy pubblicata nel gennaio 1964
SILVIA ROMANO
Université Marc Bloch
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales
Dipartimento di Lingue – SCM
Istituto Superiore Interpreti Traduttori
Corso di Specializzazione in Traduzione
Primo supervisore: professor Bruno OSIMO
Secondo supervisore: professor Cesare NARICI
Master: Langages, Cultures et Sociétés
Mention: Langues et Interculturalité
Spécialité: Traduction professionnelle et Interprétation de conférence
Parcours: Traduction littéraire
estate 2009
© Playboy, 1963
© Vintage International per il commento introduttivo, 1973
© Silvia Romano per l’edizione italiana, 2009
A milder, easier temper permeates today the expression of my opinions, however strong; and this is as it should be.
Vladimir Nabókov
Montreux, 1973
Vladimir Nabókov: Candid Conversation
Intervista a Playboy pubblicata nel gennaio 1964
1. Abstract
This thesis consists in the translation into Italian of Vladimir Nabókov’s interview with Alvin Toffler. The interview originally appeared in Playboy magazine on January 1964 and is one of the 22 included by Nabókov in his book Strong Opinions. Alvin Toffler travelled to Montreux for a week where he met Nabókov every afternoon for half an hour but was never allowed to interview him face to face. The interviewer’s questions were sent to Nabókov in writing and he answered to them in writing and had to be reproduced verbatim. Such were the three absolute conditions.
2. Sommario
1. Abstract 5
2. Sommario 7
3. Traduzione con testo a fronte 9
4. Postfazione 63
4.1. Il nudo non fa la rivista 64
4.2 Un’intervista particolare 64
4.3 Analisi testuale 65
4.4 Analisi traduttologica 67
4.4.1 Analisi linguistica 67
4.4.2 Analisi culturale 68
4.4.3 Il lettore modello 70
4.4.4 La dominante 71
4.4.5 Il residuo traduttivo 72
4.4.6 Egreto perambis doribus 73
4.4.7 Alcune scelte traduttive 74
Riferimenti bibliografici 81
3. Traduzione con testo a fronte
3
This exchange with Alvin Toffler appeared in Playboy for January, 1964. Great trouble was taken on both sides to achieve the illusion of a spontaneous conversation. Actually, my contribution as printed conforms meticulously to the answers, every word of which I had written in longhand before having them typed for submission to Toffler when he came to Montreux in mid-March, 1963. The present text takes into account the order of my interviewer’s questions as well as the fact that a couple of consecutive pages of my typescript were apparently lost in transit. Egreto perambis doribus!
With the American publication of Lolita in 1958, your fame and fortune mushroomed almost overnight from high repute among the literary cognoscenti―which you had enjoyed for more than 30 years―to both acclaim and abuse as the world-renowned author of a sensational bestseller. In the aftermath of this cause celebre, do you ever regret having written Lolita?
On the contrary, I shudder retrospectively when I recall that there was a moment, in 1950, and again in 1951, when I was on the point of burning Humbert Humbert’s little black diary. No, I shall never regret Lolita. She was like the composition of a beautiful puzzle―its composition and its solution at the same time, since one is a mirror view of the other, depending on the way you look. Of course she completely eclipsed my other works―at least those I wrote in English: The Real Life of Sebastian Knight, Bend Sinister, my short stories, my book of recollections; but I cannot grudge her this. There is a queer, tender charm about that mythical nymphet.
3
Questo scambio con Alvin Toffler è apparso su Playboy di gennaio del 1964. Entrambe le parti hanno fatto un grande sforzo per raggiungere l’illusione di una conversazione spontanea. In realtà, il mio contributo nella forma qui stampata è conforme in modo meticoloso alle risposte, di cui avevo scritto ogni parola a mano e poi a macchina per sottoporla a Toffler quando è venuto a Montreux a metà di marzo del 1963. Il testo che segue prende in considerazione l’ordine delle domande del mio intervistatore così come il fatto che nel passaggio pare siano andate perse un paio di pagine consecutive della mia trascrizione. Egreto perambis doribus!
Con la pubblicazione americana di Lolita nel 1958, la sua fama e la sua fortuna si sono estese quasi dal giorno alla notte da un’alta reputazione tra i connoisseur letterati – della quale lei aveva goduto per più di trent’anni – all’acclamazione ma anche agli insulti come l’autore famoso in tutto il mondo di un best seller sensazionale. Dopo questa causa celebree, rimpiange mai di aver scritto Lolita?
Al contrario, quando ricordo che ci fu un momento, nel 1950, e poi ancora nel 1951, in cui fui sul punto di bruciare il piccolo diario nero di Humbert Humbert retrospettivamente mi vengono i brividi. No, non rimpiangerò mai Lolita. È stata come la composizione di un bellissimo puzzle – la sua composizione e soluzione allo stesso tempo, dato che una è il riflesso dell’altra, a seconda del modo in cui la si guarda. Naturalmente ha del tutto eclissato le altre mie opere – per lo meno quelle che ho scritto in inglese: La vera vita di Sebastiano Knight, I Bastardi, i miei racconti, il mio libro di memorie, ma non posso portarle rancore per questo. C’è uno strano, dolce fascino che aleggia intorno a quella mitica ninfetta.
Though many readers and reviewers would disagree that her charm is tender, few would deny that it is queer―so much so that when director Stanley Kubrick proposed his plan to make a movie of Lolita, you were quoted as saying, “Of course they’ll have to change the plot. Perhaps they will make Lolita a dwarfess. Or they will make her I6 and Humbert 26. ” Though you finally wrote the screenplay yourself, several reviewers took the film to task for watering down the central relationship. Were you satisfied with the final product?
I thought the movie was absolutely first-rate. The four main actors deserve the very highest praise. Sue Lyon bringing that breakfast tray or childishly pulling on her sweater in the car―these are moments of unforgettable acting and directing. The killing of Quilty is a masterpiece, and so is the death of Mrs. Haze. I must point out, though, that I had nothing to do with the actual production. If I had, I might have insisted on stressing certain things that were not stressed―for example, the different motels at which they stayed. All I did was write the screenplay, a preponderating portion of which was used by Kubrick. The “watering down,” if any, did not come from my aspergillum.
Do you feel that Lolita’s twofold success has affected your life for the better or for the worse?
I gave up teaching―that’s about all in the way of change. Mind you, I loved teaching, I loved Cornell, I loved composing and delivering my lectures on Russian writers and European great books. But around 60, and especially in winter, one begins to find hard the physical process of teaching, the getting up at a fixed hour every other morning, the struggle with the snow in the driveway, the march through long corridors to the classroom, the effort of drawing on the blackboard a map of James Joyce’s Dublin or the arrangement of the semi-sleeping car of the St. Petersburg-Moscow express in the early I870s―without an understanding of which neither Ulysses nor Anna Karenin, respectively, makes sense. For some reason my most vivid memories concern examinations. Big amphitheater in Goldwin Smith.
Benché molti lettori e recensori non siano d’accordo con il fatto che il fascino di Lolita è dolce, in pochi negherebbero che è strano – tanto più che quando il regista Stanley Kubrick le ha proposto di trarre un film da Lolita, si dice che lei si sia pronunciato così: «Di certo dovranno cambiare la storia. Forse faranno di Lolita una nana. O faranno di lei una sedicenne e di Humbert un ventiseienne». Benché alla fine sia stato lei a scrivere la sceneggiatura, molti recensori hanno criticato il film perché annacqua la relazione principale. Lei è soddisfatto del prodotto finale?
Ritengo che il film sia assolutamente di prim’ordine. I quattro attori principali meritano grandissimi elogi. Sue Lyon che porta quel vassoio per la colazione o che gioca in modo infantile con il maglione in macchina – questi sono momenti di recitazione e regia indimenticabile. L’uccisione di Quilty è un capolavoro, così come la morte di Mrs Haze. Devo sottolineare, però, che non ho avuto niente a che fare con la produzione vera e propria. In quel caso, forse avrei insistito per dare risalto a certe cose che non sono state messe in risalto – per esempio, i diversi motel nei quali sono stati. Mi sono limitato a scrivere la sceneggiatura, di cui Kubrick ha usato una parte cospicua. L’“annacquamento” se c’è stato, non è venuto dal mio aspersorio.
Crede che il duplice successo di Lolita abbia avuto sulla sua vita un effetto positivo o negativo?
Ho smesso di insegnare – questo è praticamente l’unico cambiamento che c’è stato. Si badi che amavo insegnare, amavo la Cornell, amavo preparare e tenere le lezioni sugli scrittori russi e i grandi classici europei. Ma quando ci si avvicina ai sessanta, e specialmente in inverno, il processo fisico dell’insegnamento, la sveglia a orari prestabiliti una mattina su due, doversi fare strada nella neve nel vialetto davanti a casa, la marcia per i lunghi corridoi per andare in aula, lo sforzo di disegnare sulla lavagna una mappa della Dublino di James Joyce o la sistemazione nella carrozza cuccette dell’espresso San Pietroburgo-Mosca poco dopo il 1870 – senza la cui comprensione hanno rispettivamente senso né Ulisse né Anna Karenina – tutto questo comincia a pesarmi. Per qualche ragione i miei ricordi più vividi riguardano gli esami. Un grande anfiteatro nella Goldwin Smith.
Exam from 8 a.m. to 10:30. About 150 students―unwashed, unshaven young males and reasonably well-groomed young females. A general sense of tedium and disaster. Half-past eight. Little coughs, the clearing of nervous throats, coming in clusters of sound, rustling of pages. Some of the martyrs plunged in meditation, their arms locked behind their heads. I meet a dull gaze directed at me, seeing in me with hope and hate the source of forbidden knowledge. Girl in glasses comes up to my desk to ask: “Professor Kafka, do you want us to say that …? Or do you want us to answer only the first part of the question?” The great fraternity of C-minus, backbone of the nation, steadily scribbling on. A rustle arising simultaneously, the majority turning a page in their bluebooks, good teamwork. The shaking of a cramped wrist, the failing ink, the deodorant that breaks down. When I catch eyes directed at me, they are forthwith raised to the ceiling in pious meditation. Windowpanes getting misty. Boys peeling off sweaters. Girls chewing gum in rapid cadence. Ten minutes, five, three, time’s up.
Citing in Lolita the same kind of acid-etched scene you’ve just described, many critics have called the book a masterful satiric social commentary on America. Are they right?
Well, I can only repeat that I have neither the intent nor the temperament of a moral or social satirist. Whether or not critics think that in Lolita I am ridiculing human folly leaves me supremely indifferent. But I am annoyed when the glad news is spread that I am ridiculing America.
L’esame dalle 8 alle 10.30 del mattino. Circa 150 studenti – giovani maschi che non si sono lavati né fatti la barba e giovani femmine abbastanza curate. Una sensazione generale di noia e disastro. Otto e mezza. Piccoli colpi di tosse, nervosi schiarimenti di gola, che arrivano in un mucchio di rumori, fruscii di pagine. Alcuni dei martiri immersi in meditazione, le braccia incrociate dietro la testa. Incontro uno sguardo ottuso rivolto a me, che vede in me con speranza e odio la fonte della conoscenza proibita. Una ragazza con gli occhiali viene alla mia scrivania e mi chiede: «Professor Kafka, vuole che diciamo che… O vuole che rispondiamo solo alla prima parte della domanda»? La grande confraternita dei C-meno , colonna portante della nazione, scribacchia costantemente. Un fruscio che si leva simultaneamente, la maggior parte che gira la pagina del blue book , buon lavoro di squadra. Un polso indolenzito che viene scosso, l’inchiostro che finisce, il deodorante che non fa più effetto. Quando sorprendo occhi rivolti a me, vengono immediatamente alzati al soffitto in pia meditazione. Vetri che si annebbiano. Ragazzi che si levano il maglione. Ragazze che masticano gomme in una cadenza rapida. Dieci minuti, cinque, tre, è scaduto il tempo.
Molti critici, riferendosi allo stesso tipo di scena corrosa dall’acido che ha appena descritto presente in Lolita, hanno definito questo libro un magistrale commentario socio-satirico sull’America. Hanno ragione?
Beh, posso solo ribadire che non ho né l’intenzione né l’indole di un satirista morale o sociale. Che i critici pensino o meno che in Lolita io stia ridicolizzando la follia umana mi lascia affatto indifferente. Ma quando viene diffusa la gaia notizia che sto ridicolizzando l’America, sono infastidito.
But haven’t you written yourself that there is “nothing more exhilarating than American Philistine vulgarity”?
No, I did not say that. That phrase has been lifted out of context, and, like a round, deep-sea fish, has burst in the process. If you look up my little after-piece, “On a Book Entitled Lolita,” which I appended to the novel, you will see that what I really said was that in regard to Philistine vulgarity―which I do feel is most exhilarating―no difference exists between American and European manners. I go on to say that a proletarian from Chicago can be just as Philistine as an English duke.
Many readers have concluded that the Philistinism you seem to find the most exhilarating is that of America’s sexual mores.
Sex as an institution, sex as a general notion, sex as a problem, sex as a platitude―all this is something I find too tedious for words. Let us skip sex.
Have you ever been psychoanalyzed?
Have I been what?
Subjected to psychoanalytical examination.
Why, good God?
In order to see how it is done. Some critics have felt that your barbed comments about the fashionability of Freudianism, as practiced by American analysts, suggest a contempt based upon familiarity.
Bookish familiarity only. The ordeal itself is much too silly and disgusting to be contemplated even as a joke. Freudism and all it has tainted with its grotesque implications and methods appears to me to be one of the vilest deceits practiced by people on themselves and on others. I reject it utterly, along with a few other medieval items still adored by the ignorant, the conventional, or the very sick.
Ma non è stato proprio lei a scrivere che non c’è «niente di più esilarante della filistea volgarità americana»?
No, non ho detto questo. Quella frase è stata estrapolata dal contesto, ed è scoppiata, come un pesce rotondo d’acqua profonda. Se lei dà un’occhiata alla mia breve postfazione, A proposito di un libro intitolato Lolita, che ho messo in appendice al romanzo, vedrà che quel che ho detto veramente è che non c’è differenza tra le buone maniere americane ed europee riguardo alla volgarità filistea – che ritengo sia davvero molto esilarante. Dico poi che un proletario di Chicago può essere filisteo quanto un duca inglese.
Molti lettori hanno tratto la conclusione che il filisteismo che lei sembra trovare più esilarante è quello dei costumi sessuali dell’America.
Sesso come istituzione, sesso come concetto generale, sesso come problema, sesso come cliché – tutto ciò è qualcosa che ritengo troppo noioso da mettere in parole. Lasciamo perdere il sesso.
Lei è mai stato psicoanalizzato?
Sono stato cosa?
Sottomesso a un esame psicoanalitico.
Buon Dio, perché?
Per vedere come avviene. Alcuni critici ritengono che i suoi commenti sferzanti sulla moda del freudismo, così come lo praticano gli analisti americani, facciano pensare a un disprezzo dovuto alla familiarità.
Familiarità solo libresca. Già il solo supplizio è troppo stupido e disgustoso per essere contemplato anche solo per scherzo. Il freudismo e tutto ciò che ha contaminato con le sue implicazioni e i suoi metodi grotteschi mi sembra uno dei più vili inganni che la gente impone a sé stessa e agli altri. Lo rifiuto completamente, insieme a qualche altro oggetto medievale ancora adorato dagli ignoranti, dai convenzionali, o dalle persone molto malate.
Speaking of the very sick, you suggested in Lolita that Humbert Humbert’s appetite for nymphets is the result of an unrequited childhood love affair; in Invitation to a Beheading you wrote about a 12-year-old girl, Emmie, who is erotically interested in a man twice her age; and in Bend Sinister your protagonist dreams that he is “surreptitiously enjoying Mariette (his maid) while she sat, wincing a little, in his lap during the rehearsal of a play in which she was supposed to be his daughter. ” Some critics, in poring over your works for clues to your personality, have pointed to this recurrent theme as evidence of an unwholesome preoccupation on your part with the subject of sexual attraction between pubescent girls and middle-aged men. Do you feel that there may be some truth in this charge?
I think it would be more correct to say that had I not written Lolita, readers would not have started finding nymphets in my other works and in their own households. I find it very amusing when a friendly, polite person says to me―probably just in order to be friendly and polite―”Mr. Naborkov,” or “Mr. Nabahkov,” or “Mr. Nabkov” or “Mr. Nabohkov,” depending on his linguistic abilities, “I have a little daughter who is a regular Lolita.” People tend to underestimate the power of my imagination and my capacity of evolving serial selves in my writings. And then, of course, there is that special type of critic, the ferrety, human-interest fiend, the jolly vulgarian. Someone, for instance, discovered telltale affinities between Humbert’s boyhood romance on the Riviera and my own recollections about little Colette, with whom I built damp sand castles in Biarritz when I was ten. Somber Humbert was, of course, thirteen and in the throes of a pretty extravagant sexual excitement, whereas my own romance with Colette had no trace of erotic desire and indeed was perfectly common-place and normal. And, of course, at nine and ten years of age, in that set, in those times, we knew nothing whatsoever about the false facts of life that are imparted nowadays to infants by progressive parents.
A proposito delle persone molto malate, in Lolita ha suggerito che la predilezione di Humbert Humbert per le ninfette è conseguenza di un amore infantile non ricambiato; in Invito ad una decapitazione lei ha scritto di una ragazzina di dodici anni, Emmie, che ha un interesse erotico per un uomo che ha il doppio della sua età; e nei Bastardi il suo protagonista sogna di «godere segretamente di Mariette (la sua cameriera) mentre è seduta sulle sue gambe, trasalendo un poco, durante le prove di uno spettacolo nel quale lei doveva interpretare sua figlia». Alcuni critici, esaminando le sue opere in cerca di indizi sulla sua personalità, hanno indicato questo tema ricorrente come prova di una fissazione malsana da parte sua per l’argomento dell’attrazione sessuale tra ragazze pubescenti e uomini di mezza età. Ritiene che in questa accusa ci possa essere del vero?
Credo che sarebbe più corretto dire che se non avessi scritto Lolita, i lettori non avrebbero cominciato a trovare ninfette nelle altre mie opere e nelle loro famiglie. Trovo molto divertente che una persona simpatica, gentile mi dica – forse solo per essere simpatico e gentile – «Mr. Nabórkov», o «Mr. Nabáhkov», o «Mr. Nabkov», o «Nabóhkov», a seconda delle sue abilità linguistiche, «ho una figlia piccola che è una vera e propria Lolita». La gente ha la tendenza a sottovalutare il potere della mia immaginazione e la mia capacità di sviluppare personalità seriali nelle mie opere. E poi, ovviamente, c’è quel tipo speciale di critico, tenace, ossessionato dagli interessi dell’umanità, quello proprio volgare. Qualcuno, per esempio, ha scoperto affinità rivelatrici tra l’idillio amoroso di Humbert da ragazzo sulla Riviera e il mio ricordo della piccola Colette, con la quale ho costruito umidi castelli di sabbia a Biarritz quando avevo dieci anni. Il cupo Humbert, ovviamente, aveva tredici anni ed era nel pieno di un’eccitazione sessuale piuttosto esorbitante, mentre nel mio idillio amoroso con Colette non c’era traccia di desiderio erotico ed era anzi perfettamente ordinario e normale. E, ovviamente, a nove o dieci anni, in quel contesto, in quegli anni, non sapevamo nulla dei falsi fatti della vita che oggigiorno genitori progressisti insegnano ai bambini.
Why false?
Because the imagination of a small child―especially a town child―at once distorts, stylizes, or otherwise alters the bizarre things he is told about the busy bee, which neither he nor his parents can distinguish from a bumblebee, anyway.
What one critic has termed your “almost obsessive attention to the phrasing, rhythm, cadence and connotation of words” is evident even in the selection of names for your own celebrated bee and bumblebee―Lolita and Humbert Humbert. How did they occur to you?
For my nymphet I needed a diminutive with a lyrical lilt to it. One of the most limpid and luminous letters is “L”. The suffix “-ita” has a lot of Latin tenderness, and this I required too. Hence: Lolita. However, it should not be pronounced as you and most Americans pronounce it: Low-lee-ta, with a heavy, clammy “L” and a long “o”. No, the first syllable should be as in “lollipop”, the “L” liquid and delicate, the “lee” not too sharp. Spaniards and Italians pronounce it, of course, with exactly the necessary note of archness and caress. Another consideration was the welcome murmur of its source name, the fountain name: those roses and tears in “Dolores.” My little girl’s heartrending fate had to be taken into account together with the cuteness and limpidity. Dolores also provided her with another, plainer, more familiar and infantile diminutive: Dolly, which went nicely with the surname “Haze,” where Irish mists blend with a German bunny―I mean, a small German hare.
You’re making a word-playful reference, of course, to the German term for rabbit―Hase. But what inspired you to dub Lolita’s aging inamorato with such engaging redundancy?
Perché falsi?
Perché l’immaginazione di un bambino – specialmente un bambino di città – a un tempo distorce, stilizza, o comunque altera le cose bizzarre che gli vengono dette sull’ape operosa, che, tra parentesi, né lui né i suoi genitori sanno distinguere dal bombo.
Quello che un critico ha definito la sua « attenzione quasi ossessiva per il fraseggio, il ritmo, la cadenza e la connotazione delle parole» è evidente perfino nella scelta dei nomi di Lolita e Humbert Humbert – i suoi famosi ape e bombo. Come le sono venuti in mente?
Per la mia ninfetta mi serviva un diminutivo che avesse un’inflessione lirica. Una delle lettere più limpide e luminose è la «L». Nel suffisso «-ita» c’è molta della dolcezza latinoamericana , e avevo bisogno anche di questo. Quindi: Lolita. Comunque, non dovrebbe essere pronunciato come lei e la maggior parte degli americani lo pronunciano: Low-lee-ta con una pesante e umidiccia «L» e una lunga «O». No, la prima sillaba dovrebbe essere come in «lollipop», la «L» liquida e delicata, il «lee» non troppo acuto. Spagnoli e italiani lo pronunciano, è ovvio, esattamente con il giusto tocco di malizia e carezza. Un’altra considerazione è stata il mormorio gradevole del nome fonte, il nome fontana: quelle rose e lacrime in «Dolores». Insieme alla grazia e alla limpidezza doveva essere preso in considerazione il destino strappalacrime della mia piccola bambina. Dolores le dava anche un altro diminutivo, più semplice, più familiare e infantile: Dolly, che si sposava bene con il cognome «Haze», dove le nebbie irlandesi si mischiano a un coniglio tedesco – voglio dire, a un leprotto tedesco.
Sta facendo un riferimento giocoso, ovviamente, alla parola tedesca per coniglio – Hase. Ma che cosa la ha ispirata a dare al maturo innamorato di Lolita un nome di tale impegnativa ridondanza?
That, too, was easy. The double rumble is, I think, very nasty, very suggestive. It is a hateful name for a hateful person. It is also a kingly name, and I did need a royal vibration for Humbert the Fierce and Humbert the Humble. Lends itself also to a number of puns. And the execrable diminutive “Hum” is on a par, socially and emotionally, with “Lo,” as her mother calls her.
Another critic has written of you that “the task of sifting and selecting just the right succession of words from that multilingual memory, and of arranging their many-mirrored nuances into the proper juxtapositions, must be psychically exhausting work. ” Which of all your books, in this sense, would you say was the most difficult to write?
Oh, Lolita, naturally. I lacked the necessary information―that was the initial difficulty. I did not know any American 12-year-old girls, and I did not know America; I had to invent America and Lolita. It had taken me some forty years to invent Russia and Western Europe, and now I was faced by a similar task, with a lesser amount of time at my disposal. The obtaining of such local ingredients as would allow me to inject average “reality” into the brew of individual fancy proved, at fifty, a much more difficult process than it had been in the Europe of my youth.
Though born in Russia, you have lived and worked for many years in America as well as in Europe. Do you feel any strong sense of national identity?
I am an American writer, born in Russia and educated in England where I studied French literature, before spending fifteen years in Germany. I came to America in 1940 and decided to become an American citizen, and make America my home. It so happened that I was immediately exposed to the very best in America, to its rich intellectual life and to its easygoing, good-natured atmosphere. I immersed myself in its great libraries and its Grand Canyon. I worked in the laboratories of its zoological museums. I acquired more friends than I ever had in Europe.
Anche quello è stato facile. Il doppio rombo è, credo, molto cattivo, molto evocativo. È un nome odioso per una persona odiosa. È anche un nome da re, e io avevo proprio bisogno di una vibrazione regale per Humbert il Feroce e Humbert l’Umile. Si presta anche a numerosi giochi di parole. E il diminutivo spregiativo «Hum» è al pari, da un punto di vista sociale ed emozionale, di «Lo», come la chiama sua madre.
Un altro critico ha scritto di lei che «l’esercizio di passare al setaccio e selezionare esattamente la giusta successione di parole dalla memoria multilingue, e di disporre le loro nuance dai molti riflessi nella corretta giustapposizione, deve essere un lavoro psichicamente estenuante». Quale tra tutti i suoi libri, in questo senso, direbbe sia stato il più difficile da scrivere?
Beh, Lolita, naturalmente. Mi mancavano le informazioni necessarie – quella è stata la difficoltà iniziale. Non conoscevo nessuna dodicenne americana, né conoscevo l’America; ho dovuto inventare l’America e Lolita. Mi ci erano voluti quarant’anni per inventare la Russia e l’Europa occidentale, e adesso avevo davanti un compito simile, con meno tempo a disposizione. Ottenere ingredienti locali che mi permettessero di iniettare una “realtà” ordinaria nel calderone dell’immaginazione individuale si è dimostrato, a cinquant’anni, un processo molto più difficile di quanto non fosse stato nell’Europa della mia gioventù.
Anche se è nato in Russia, lei ha vissuto e lavorato per molti anni in America e in Europa. Sente di provare un forte senso di identità nazionale?
Io sono uno scrittore americano, nato in Russia, e ho ricevuto un’istruzione in Inghilterra dove ho studiato la letteratura francese, prima di trascorrere quindici anni in Germania. Sono venuto in America nel 1940 e ho deciso di diventare cittadino americano, e di fare dell’America la mia patria. È successo così che in America sono stato immediatamente esposto al meglio, alla sua ricca vita intellettuale e alla sua atmosfera rilassata, bonaria. Mi sono immerso nelle sue grandi biblioteche e nel suo Grand Canyon. Ho lavorato nei laboratori dei suoi musei zoologici. Ho avuto più amici di quanti non ne abbia mai avuti in Europa.
My books―old books and new ones―found some admirable readers. I became as stout as Cortez―mainly because I quit smoking and started to munch molasses candy instead, with the result that my weight went up from my usual 140 to a monumental and cheerful 200. In consequence, I am one-third American―good American flesh keeping me warm and safe.
You spent 20 years in America, and yet you never owned a home or had a really settled establishment there. Your friends report that you camped impermanently in motels, cabins, furnished apartments and the rented homes of professors away on leave. Did you feel so restless or so alien that the idea of settling down anywhere disturbed you?
The main reason, the background reason, is, I suppose, that nothing short of a replica of my childhood surroundings would have satisfied me. I would never manage to match my memories correctly―so why trouble with hopeless approximations? Then there are some special considerations: for instance, the question of impetus, the habit of impetus. I propelled myself out of Russia so vigorously, with such indignant force, that I have been rolling on and on ever since. True, I have rolled and lived to become that appetizing thing, a “full professor,” but at heart I have always remained a lean “visiting lecturer.” The few times I said to myself anywhere: “Now, that’s a nice spot for a permanent home,” I would immediately hear in my mind the thunder of an avalanche carrying away the hundreds of far places which I would destroy by the very act of settling in one particular nook of the earth.
I miei libri – libri vecchi e nuovi – hanno trovato lettori ammirevoli. Sono diventato robusto come Cortés – principalmente perché ho smesso di fumare e invece ho iniziato a mangiucchiare caramelle alla melassa, con il risultato che il mio peso è aumentato dai miei normali sessantacinque ai monumentali e allegri novanta. Di conseguenza, sono per un terzo americano – buona carne americana che mi tiene al caldo e al sicuro.
Lei ha trascorso vent’ anni in America, e nonostante questo non ha mai avuto una casa sua o si è mai veramente stabilito lì. I suoi amici raccontano che lei si è accampato in modo transitorio in motel, casupole, appartamenti ammobiliati e case in affitto di professori in sabbatico. Si sentiva così irrequieto o estraneo che l’idea di stabilirsi in modo definitivo in un luogo la disturbava?
La ragione principale, la ragione di fondo, è, credo, che non mi avrebbe soddisfatto niente di inferiore a una replica dell’ambiente della mia infanzia. Non avrei mai potuto associare i miei ricordi in modo corretto – quindi perché prendersi il disturbo con approssimazioni senza speranza? Poi ci sono alcune considerazioni speciali: per esempio, la questione dell’impeto, l’abitudine all’impeto. I mi sono spinto fuori dalla Russia in modo così vigoroso, con una forza così indignata, che da allora non ho fatto altro che girare. Vero, ho girato e vissuto per diventare quella cosa appetitosa, un «full professor » , ma nel cuore rimango sempre un piccolo «visiting lecturer ». Le poche volte in cui da qualche parte mi sono detto: «Ecco, questo è un bel posto per una casa definitiva», sentivo subito nella mia mente il rombo di una valanga che spazza via le centinaia di posti lontani che distruggerei con l’atto stesso di stabilirmi in una particolare nicchia della terra.
And finally, I don’t much care for furniture, for tables and chairs and lamps and rugs and things―perhaps because in my opulent childhood I was taught to regard with amused contempt any too-earnest attachment to material wealth, which is why I felt no regret and no bitterness when the Revolution abolished that wealth.
You lived in Russia for twenty years, in West Europe for 20 years, and in America for twenty years. But in I960, after the success of Lolita, you moved to France and Switzerland and have not returned to the U. S. since. Does this mean, despite your self-identification as an American writer, that you consider your American period over?
I am living in Switzerland for purely private reasons―family reasons and certain professional ones too, such as some special research for a special book. I hope to return very soon to America―back to its library stacks and mountain passes. An ideal arrangement would be an absolutely soundproofed flat in New York, on a top floor―no feet walking above, no soft music anywhere―and a bungalow in the Southwest. Sometimes I think it might be fun to adorn a university again, residing and writing there, not teaching, or at least not teaching regularly.
Meanwhile you remain secluded―and somewhat sedentary, from all reports―in your hotel suite. How do you spend your time?
I awake around seven in winter: my alarm clock is an Alpine chough―big, glossy, black thing with big yellow beak―which visits the balcony and emits a most melodious chuckle. For a while I lie in bed mentally revising and planning things. Around eight: shave, breakfast, enthroned meditation, and bath―in that order. Then I work till lunch in my study, taking time out for a short stroll with my wife along the lake. Practically all the famous Russian writers of the nineteenth century have rambled here at one time or another. Zhukovski, Gogol, Dostoevski, Tolstoy―who courted the hotel chambermaids to the detriment of his health―and many Russian poets. But then, as much could be said of Nice or Rome.
E per concludere, non mi interessano molto l’arredamento, i tavoli e le sedie e le lampade e i tappeti e le cose – forse perché nella mia infanzia opulenta mi è stato insegnato a guardare con divertito disprezzo qualunque attaccamento troppo sincero alla ricchezza materiale, motivo per cui quando la Rivoluzione abolì quella ricchezza non ho provato nessun rimpianto né dispiacere.
Lei ha vissuto per vent’anni in Russia, per vent’anni in Europa occidentale, e per vent’anni in America. Ma nel 1960, dopo il successo di Lolita, si è trasferito in Francia e in Svizzera e da allora non è più tornato negli Stati Uniti. Questo significa, nonostante si consideri uno scrittore americano, che lei ritiene concluso il suo periodo americano?
Vivo in Svizzera per ragioni puramente private – ragioni familiari e anche alcune professionali, come una ricerca speciale per un libro speciale. Spero di tornare molto presto in America – tornare alle scaffalature delle biblioteche e ai passi di montagna. Una sistemazione ideale sarebbe un appartamento completamente insonorizzato a New York, all’ultimo piano – nessun piede che cammina sopra, niente musica soft da nessuna parte – e un bungalow nel South-West. A volte penso che sarebbe divertente fungere ancora da ornamento a un’università, risiedere e scrivere lì, non insegnare, o almeno non insegnare regolarmente.
Nel frattempo rimane recluso – e in un certo senso sedentario, stando a tutte le dichiarazioni – nella sua suite d’albergo. Come trascorre il tempo?
In inverno mi sveglio verso le sette: la mia sveglia è un gracchio alpino – una cosa grande, lucida, nera con un grande becco giallo – che visita il balcone e ridacchia in un modo molto melodioso. Per un po’ resto a letto a ripassare mentalmente e fare piani. Attorno alle otto: barba, colazione, meditazione seduto sul trono, e bagno – in quest’ordine. Poi lavoro fino a pranzo nel mio studio, prendendomi un po’ di tempo per una breve passeggiata lungo il lago con mia moglie. A quasi tutti gli scrittori russi famosi dell’Ottocento è capitato di passeggiare qui. Žukovskij, Gogol´, Dostoevskij, Tolstoj – che hanno fatto la corte alle cameriere degli alberghi a detrimento della salute – e molti poeti russi. Ma d’altra parte, lo stesso si potrebbe dire di Nizza o Roma.
We lunch around one p.m., and I am back at my desk by half-past one and work steadily till half-past six. Then a stroll to a newsstand for the English papers,
and dinner at seven. No work after dinner. And bed around nine. I read till half-past eleven, and then tussle with insomnia till one A.M. About twice a week I have a good, long nightmare with unpleasant characters imported from earlier dreams, appearing in more or less iterative surroundings―kaleidoscopic arrangements of broken impressions, fragments of day thoughts, and irresponsible mechanical images, utterly lacking any possible Freudian implication or explication, but singularly akin to the procession of changing figures that one usually sees on the inner palpebral screen when closing one’s weary eyes.
Funny that witch doctors and their patients have never hit on that simple and absolutely satisfying explanation of dreaming. Is it true that you write standing up, and that you write in longhand rather than on a typewriter?
Yes. I never learned to type. I generally start the day at a lovely old-fashioned lectern I have in my study. Later on, when I feel gravity nibbling at my calves, I settle down in a comfortable armchair alongside an ordinary writing desk; and finally, when gravity begins climbing up my spine, I lie down on a couch in a corner of my small study. It is a pleasant solar routine. But when I was young, in my twenties and early thirties, I would often stay all day in bed, smoking and writing. Now things have changed. Horizontal prose, vertical verse, and sedent scholia keep swapping qualifiers and spoiling the alliteration.
Can you tell us something more about the actual creative process involved in the germination of a book―perhaps by reading a few random notes for or excerpts from a work in progress?
Certainly not. No fetus should undergo an exploratory operation. But I can do something else.
Pranziamo verso l’una, e sono di nuovo alla scrivania per l’una e mezza e lavoro senza sosta fino alle sei e mezza. Poi una passeggiata all’edicola a comprare i giornali inglesi, e cena alle sette. Niente lavoro dopo cena. E a letto verso le nove. Leggo fino alle undici e mezza, e poi litigo con l’insonnia fino all’una. Circa due volte a settimana ho un bell’incubo, lungo, con personaggi spiacevoli importati da sogni precedenti, che appaiono in ambienti più o meno ripetitivi – composizioni caleidoscopiche di impressioni rotte, frammenti di pensieri fatti di giorno, e immagini meccaniche irresponsabili, del tutto prive di una possibile implicazione o esplicazione freudiana, ma eccezionalmente simili alla processione di forme mutevoli che di solito si vedono nello schermo interno della palpebra quando si chiudono gli occhi stanchi.
Curioso che gli stregoni e i loro pazienti non abbiano mai pensato a quella semplice e del tutto soddisfacente spiegazione per i sogni. È vero che lei scrive stando in piedi, e che preferisce scrivere a mano che con la macchina da scrivere?
Sì. Non ho mai imparato a battere a macchina. Generalmente inizio la giornata a un delizioso leggio di una volta che ho nello studio. Più tardi, quando sento la gravità mordicchiarmi i polpacci, mi accomodo su una confortevole poltrona di fianco a una scrivania normale; e infine, quando la gravità mi comincia a salire su per la spina dorsale, mi sdraio su un divano in un angolo del mio studiolo. È una piacevole routine solare. Ma quando ero giovane, a vent’anni e per un po’ anche a trenta, spesso stavo tutto il giorno a letto, a fumare e scrivere. Adesso le cose sono cambiate. Prosa orizzontale, verso verticale, e glosse da seduto continuano a farmi spostare gli aggettivi e a rovinare l’allitterazione.
Ci può dire qualcosa di più sull’effettivo processo creativo che riguarda la germinazione di un libro – magari leggendoci qualche appunto qua e là o qualche estratto da qualcosa a cui sta lavorando?
Ovviamente no. Non bisognerebbe sottoporre nessun feto a un’operazione esplorativa. Ma posso fare un’altra cosa.
This box contains index cards with some notes I made at various times more or less recently and discarded when writing Pale Fire. It’s a little batch of rejects. Help yourself. “Selene, the moon. Selenginsk, an old town in Siberia: moon-rocket town” … “Berry: the black knob on the bill of the mute swan” … “Dropworm: a small caterpillar hanging on a thread” … “In The New Bon Ton Magazine, volume five, 1820, page 312, prostitutes are termed ‘girls of the town'” … “Youth dreams: forgot pants; old man dreams: forgot dentures”, … “Student explains that when reading a novel he likes to skip passages ‘so as to get his own idea about the book and not be influenced by the author'” … “Naprapathy: the ugliest word in the language.”
“And after rain, on beaded wires, one bird, two birds, three birds, and none. Muddy tires, sun” … “Time without consciousness―lower animal world; time with consciousness―man; consciousness without time―some still higher state” … “We think not in words but in shadows of words. James Joyce’s mistake in those otherwise marvelous mental soliloquies of his consists in that he gives too much verbal body to thoughts” … “Parody of politeness: That inimitable ‘Please’ ―’Please send me your beautiful—’ which firms idiotically address to themselves in printed forms meant for people ordering their product.” …
“Naive, nonstop, peep-peep twitter of chicks in dismal crates late, late at night, on a desolate frost-bedimmed station platform” … “The tabloid headline TORSO KILLER MAY BEAT CHAIR might be translated: ‘Celui qui tue un buste peut bien battre une chaise'” … “Newspaper vendor, handing me a magazine with my story: ‘I see you made the slicks.’ ” “Snow falling, young father out with tiny child, nose like a pink cherry. Why does a parent immediately say something to his or her child if a stranger smiles at the latter? ‘Sure,’ said the father to the infant’s interrogatory gurgle, which had been going on for some time, and would have been left to go on in the quiet falling snow, had I not smiled in passing” … “Inter-columniation: dark-blue sky between two white columns.” … “Place-name in the Orkneys: Papilio” …
Questa scatola contiene schede d’archivio con alcuni appunti che ho fatto in diversi momenti più o meno recenti e che ho scartato mentre stavo scrivendo Fuoco pallido. È un piccolo mazzo di scarti. Prenda pure. «Selene, la luna. Selenginsk, una vecchia città in Siberia: la città del razzo lunare»… «Berry: la sporgenza nera sul becco del cigno muto»… «Larva di geometride: un piccolo bruco appeso a un filo»… «Sul New Bon Ton Magazine, volume cinque, 1820, pagine 312, le prostitute sono chiamate «ragazze della città»… «Sogni che si fanno da ragazzo: dimenticarsi le mutande; sogni che si fanno da vecchio: dimenticarsi dentiere »… «Lo studente spiega che quando legge un romanzo gli piace saltare dei passi “così da farsi una sua idea del libro e non essere influenzato dall’autore”»… «Naprapatia: la parola più brutta della lingua».
«E dopo la pioggia, su fili imperlati, un uccello, due uccelli, tre uccelli, e nessuno. Copertoni infangati, sole»… «Tempo senza coscienza – mondo animale più basso; tempo con coscienza – uomo; coscienza senza tempo – una condizione ancora più alta»… «Non pensiamo in parole ma in ombre di parole. Lo sbaglio di James Joyce in quei suoi altrimenti magnifici soliloqui mentali consiste nel fatto che dà troppo corpo verbale ai pensieri»… «La parodia della gentilezza: Quell’inimitabile “Per favore” – “per favore mandatemi i vostri bellissimi –” che le aziende stupidamente indirizzano a sé stesse su moduli ideati per che ordina i loro prodotti». …
«Pigolio ingenuo, senza sosta, di pulcini nelle misere gabbie tardi, tardi la notte, sulla banchina desolata di una stazione oscurata dal gelo»… «Il titolo del tabloid TORSO KILLER MAY BEAT CHAIR potrebbe essere tradotto: «Celui que tue un buste peut bien battre une chaise»… «L’edicolante, passandomi una rivista con il mio racconto: “Vedo che ha conquistato le copertine dei giornali”». «Neve che cade, giovane padre in giro con il bambino piccolo, naso come una ciliegia rosa. Perché se un estraneo sorride a un bambino il genitore gli dice subito qualcosa? “Certo”, disse il padre alla risata interrogativa del neonato, che andava avanti da un po’, e a cui sarebbe stato permesso continuare nella tranquilla neve che cadeva, se io passando non avessi sorriso»… «Intercolunnio: cielo blu scuro tra due colonne bianche». … «Toponimo nelle isole Orkney: Papilio» …
“Not I, too, lived in Arcadia,’ but ‘I,’ says Death, even am in Arcadia’―legend on a shepherd’s tomb (Notes and Queries, June I3, I868, p. 56I)” … “Marat collected butterflies” … “From the aesthetic point of view, the tapeworm is certainly an undesirable boarder. The gravid segments frequently crawl out of a person’s anal canal, sometimes in chains, and have been reported a source of social embarrassment.” (Ann. N. Y. Acad. Sci. 48:558).
What inspires you to record and collect such disconnected impressions and quotations?
All I know is that at a very early stage of the novel’s development I get this urge to garner bits of straw and fluff, and eat pebbles. Nobody will ever discover how clearly a bird visualizes, or if it visualizes at all, the future nest and the eggs in it. When I remember afterwards the force that made me jot down the correct names of things, or the inches and tints of things, even before I actually needed the information, I am inclined to assume that what I call, for want of a better term, inspiration, had been already at work, mutely pointing at this or that, having me accumulate the known materials for an unknown structure. After the first shock of recognition―a sudden sense of “this is what I’m going to write”―the novel starts to breed by itself; the process goes on solely in the mind, not on paper; and to be aware of the stage it has reached at any given moment, I do not have to be conscious of every exact phrase. I feel a kind of gentle development, an uncurling inside, and I know that the details are there already, that in fact I would see them plainly if I looked closer, if I stopped the machine and opened its inner compartment; but I prefer to wait until what is loosely called inspiration has completed the task for me. There comes a moment when I am informed from within that the entire structure is finished. All I have to do now is take it down in pencil or pen.
«Non “anch’io, vissi in Arcadia,” ma “anche” dice la Morte, in Arcadia sono» – leggenda sulla tomba di un pastore (Notes and Queries giugno 1868, pagina 561)»… «Marat collezionava farfalle»… «Da un punto di vista estetico, la tenia è certamente un inquilino indesiderato. I segmenti gravidi di frequente strisciano fuori dal canale anale di una persona, a volte in catene, si dice siano fonte di imbarazzo sociale». (Ann. N.Y. Acad. Sci. 48: 558).
Che cosa la ispira a registrare e raccogliere impressioni e citazioni così sconnesse?
Tutto quello che so è che in uno dei primi stadi dell’elaborazione del romanzo sento questo impulso di mettere via paglia e laniccio, e di mangiare sassi. Nessuno scoprirà mai quanto chiaramente un uccello immagini, o addirittura se immagini, il futuro nido e le uova che ci sono dentro. Quando in seguito ricordo la forza che mi ha spinto ad annotare i nomi corretti delle cose, o i centimetri e le tinte delle cose, anche prima di avere davvero bisogno dell’informazione, sono incline a supporre che quello che io chiamo, per mancanza di una parola migliore, ispirazione, fosse già al lavoro, puntando in silenzio a questo o a quello, facendomi accumulare i materiali conosciuti per una struttura sconosciuta. Dopo lo shock iniziale del riconoscimento – un’improvvisa sensazione di «è questo che scriverò» – il romanzo comincia a crearsi da sé; il processo avanza da solo nella mia mente, non sul foglio; e per sapere quale stadio ha raggiunto in ogni preciso momento, non devo essere consapevole di ogni singola frase. Sento una specie di elaborazione delicata, qualcosa dentro che si sbroglia, e so che i dettagli ci sono già, che in effetti se guardassi più da vicino li vedrei chiaramente, se fermassi la macchina e aprissi la tasca interna; ma preferisco aspettare che quel che in modo impreciso viene chiamato ispirazione abbia completato il lavoro per me. Arriva un momento in cui vengo informato da dentro che l’intera struttura è finita. Tutto quello che devo fare è metterla giù a matita o a penna.
Since this entire structure, dimly illumined in one’s mind, can be compared to a painting, and since you do not have to work gradually from left to right for its proper perception, I may direct my flashlight at any part or particle of the picture when setting it down in writing. I do not begin my novel at the beginning. I do not reach chapter three before I reach chapter four, I do not go dutifully from one page to the next, in consecutive order; no, I pick out a bit here and a bit there, till I have filled all the gaps on paper. This is why I like writing my stories and novels on index cards, numbering them later when the whole set is complete. Every card is rewritten many times. About three cards make one typewritten page, and when finally I feel that the conceived picture has been copied by me as faithfully as physically possible―a few vacant lots always remain, alas―then I dictate the novel to my wife who types it out in triplicate.
In what sense do you copy “the conceived picture” of a novel?
A creative writer must study carefully the works of his rivals, including the Almighty. He must possess the inborn capacity not only of recombining but of re-creating the given world. In order to do this adequately, avoiding duplication of labor, the artist should know the given world. Imagination without knowledge leads no farther than the back yard of primitive art, the child’s scrawl on the fence, and the crank’s message in the market place. Art is never simple. To return to my lecturing days: I automatically gave low marks when a student used the dreadful phrase “sincere and simple”―”Flaubert writes with a style which is always simple and sincere”―under the impression that this was the greatest compliment payable to prose or poetry. When I struck the phrase out, which I did with such rage in my pencil that it ripped the paper, the student complained that this was what teachers had always taught him: “Art is simple, art is sincere.” Someday I must trace this vulgar absurdity to its source. A schoolmarm in Ohio? A progressive ass in New York?
Dato che tutta questa struttura, fiocamente illuminata nella propria mente, può essere paragonata a un quadro, e dato che non è obbligatorio lavorare gradualmente da sinistra verso destra per percepirla in modo corretto, quando mi metto a scriverla posso puntare la mia torcia su qualunque parte o particella del quadro. Non comincio il mio romanzo dall’inizio. Non arrivo al terzo capitolo prima di arrivare al quarto, non vado rigorosamente da una pagina a quella dopo, in ordine; no, scelgo un pezzo qua e un pezzo là, finché ho riempito tutti i buchi sul foglio. È per questo che mi piace scrivere i miei racconti e i romanzi sulle schede d’archivio, numerandole poi quando tutto l’insieme è completo. Ogni scheda viene riscritta diverse volte. Ci vogliono all’incirca tre schede per fare una pagina dattiloscritta, e quando finalmente sento che il quadro concepito è stato da me copiato nel modo più fisicamente fedele possibile – qualche spazio vacante rimane sempre, purtroppo – allora detto il romanzo a mia moglie che lo batte a macchina in triplice copia.
In che senso copia “il quadro concepito” di un romanzo?
Uno scrittore creativo deve studiare attentamente i lavori dei suoi rivali, compreso l’Onnipotente. Deve possedere la capacità innata non solo di ricombinare ma anche di ricreare il mondo così com’è. Per farlo in modo adeguato, evitando di fare il doppio della fatica, l’artista dovrebbe conoscere il mondo così com’è. L’immaginazione senza conoscenza non porta più lontano dell’uscita di servizio dell’arte primitiva, dello scarabocchio di un bambino sulla palizzata, e del messaggio dello scemo del villaggio sulla piazza del mercato. L’arte non è mai semplice. Per tornare al periodo in cui insegnavo: davo automaticamente voti bassi quando uno studente usava l’orrenda frase «sincero e semplice» – Flaubert scrive con uno stile che è sempre semplice e sincero – avendo l’impressione che questo fosse il più grande complimento che si potesse tributare alla prosa o alla poesia. Quando mettevo in evidenza la frase, cosa che facevo usando la matita con una rabbia tale da bucare il foglio, lo studente si lamentava perché era quello che gli insegnanti gli avevano sempre insegnato: «L’arte è semplice, l’arte è sincera». Un giorno dovrò arrivare alla fonte di questa volgare assurdità. Una maestrina in Ohio? Un cretino progressista a New York?
Because, of course, art at its greatest is fantastically deceitful and complex.
In terms of modern art, critical opinion is divided about the sincerity or deceitfulness, simplicity or complexity, of contemporary abstract painting. What is your own opinion?
I do not see any essential difference between abstract and primitive art. Both are simple and sincere. Naturally, we should not generalize in these matters: it is the individual artist that counts. But if we accept for a moment the general notion of “modern art,” then we must admit that the trouble with it is that it is so commonplace, imitative, and academic. Blurs and blotches have merely replaced the mass prettiness of a hundred years ago, pictures of Italian girls, handsome beggars, romantic ruins, and so forth. But just as among those corny oils there might occur the work of a true artist with a richer play of light and shade, with some original streak of violence or tenderness, so among the corn of primitive and abstract art one may come across a flash of great talent. Only talent interests me in paintings and books. Not general ideas, but the individual contribution.
A contribution to society?
A work of art has no importance whatever to society. It is only important to the individual, and only the individual reader is important to me. I don’t give a damn for the group, the community, the masses, and so forth. Although I do not care for the slogan “art for art’s sake”―because unfortunately such promoters of it as, for instance, Oscar Wilde and various dainty poets, were in reality rank moralists and didacticists―there can be no question that what makes a work of fiction safe from larvae and rust is not its social importance but its art, only its art.
Perché, ovviamente, l’arte al suo massimo è meravigliosamente ingannevole e complessa.
In merito all’arte moderna, l’opinione dei critici è divisa sulla sincerità o ingannevolezza, semplicità o complessità, della pittura astratta contemporanea. Lei che cosa ne pensa?
Non vedo nessuna differenza sostanziale tra l’arte primitiva e quella astratta. Entrambe sono semplici e sincere. Naturalmente, non dovremmo generalizzare su questi argomenti: è il singolo artista che conta. Ma se accettiamo per un momento il concetto generale di «arte moderna» dobbiamo ammettere che il problema è che è così ordinaria, imitativa e scolastica. Macchie e chiazze non hanno certo sostituito la bellezza di massa di cento anni fa, quadri di ragazze italiane, bei mendicanti, romantiche rovine, e via dicendo. Ma proprio come tra quei leziosi dipinti a olio potrebbe trovarsi l’opera di un vero artista con un gioco di luci e ombre più ricco, con qualche raggio di violenza o tenerezza, così tra la leziosità dell’arte primitiva e astratta ci si potrebbe imbattere in un bagliore di grande talento. Nei quadri e nei libri a me interessa solo il talento. Non le idee generali, ma il singolo contributo.
Un contributo alla società?
Un’opera d’arte non ha alcuna importanza per la società. È importante solo per il singolo, e solo il singolo lettore è importante per me. Non me ne importa nulla del gruppo, la comunità, le masse, e via discorrendo. Benché non mi stia a cuore lo slogan «l’arte per l’arte» – perché sfortunatamente i suoi promotori come, ad esempio, Oscar Wilde e numerosi poeti delicati, in realtà erano moralisti e didascalici di prim’ordine – è indiscutibile che quel che mette al sicuro un romanzo dalle larve e dalla ruggine non è la sua importanza sociale ma la sua arte, solo la sua arte.
What do you want to accomplish or leave behind―or should this be of no concern to the writer?
Well, in this matter of accomplishment, of course, I don’t have a 35-year plan or program, but I have a fair inkling of my literary afterlife. I have sensed certain hints, I have felt the breeze of certain promises. No doubt there will be ups and downs, long periods of slump. With the Devil’s connivance, I open a newspaper of 2063 and in some article on the books page I find: “Nobody reads Nabokov or Fulmerford today.” Awful question: Who is this unfortunate Fulmerford?
While we’re on the subject of self-appraisal, what do you regard as your principal failing as a writer―apart from forgetability?
Lack of spontaneity; the nuisance of parallel thoughts, second thoughts, third thoughts; inability to express myself properly in any language unless I compose every damned sentence in my bath, in my mind, at my desk.
You’re doing rather well at the moment, if we may say so.
It’s an illusion.
Your reply might be taken as confirmation of critical comments that you are “an incorrigible leg puller, ” “a mystificator, ” and “a literary agent provocateur.” How do you view yourself?
I think my favorite fact about myself is that I have never been dismayed by a critic’s bilge or bile, and have never once in my life asked or thanked a reviewer for a review. My second favorite fact or shall I stop at one?
No, please go on.
The fact that since my youth―I was 19 when I left Russia―my political creed has remained as bleak and changeless as an old gray rock. It is classical to the point of triteness.
Che cosa vuole compiere o lasciarsi alle spalle – o questo allo scrittore non dovrebbe interessare?
Beh, per quel che riguarda il compimento, ovviamente, non ho un piano o un programma di trentacinque anni, ma ho una netta sensazione di come sarà il mio aldilà letterario. Ho percepito certi indizi, ho sentito la facilità di certe promesse. Senza dubbio ci saranno alti e bassi, lunghi periodi in discesa. Con la connivenza del Diavolo, apro un quotidiano del 2063 e in un articolo nella pagina letteraria trovo: «Oggi nessuno legge più Nabókov né Fulmerford». Domanda orribile: chi è questo sfortunato Fulmerford?
Per rimanere nell’argomento dell’autostima, quali considera i suoi principali difetti come scrittore – a parte il fatto di essere dimenticabile?
Mancanza di spontaneità; la seccatura di pensieri paralleli, secondi pensieri, terzi pensieri; incapacità di esprimermi in modo corretto in qualunque lingua se non compongo ciascuna maledetta frase nel mio bagno, nella mia testa, alla mia scrivania.
Se mi è concesso, al momento se la sta cavando piuttosto bene.
È un’illusione.
La sua risposta potrebbe essere recepita come una conferma di commenti critici che lei è «un incorreggibile burlone», «un mistificatore», e un «agent provocateur letterario». Ma lei come si vede?
Credo che la cosa che preferisco di me stesso sia che non sono mai stato turbato dalle sciocchezze o suscettibilità dei critici, e nella mia vita non ho mai chiesto una recensione, né ringraziato un recensore. La seconda cosa che preferisco di me – o mi fermo alla prima?
No, la prego continui.
È che da quando ero ragazzo –quando lasciai la Russia avevo diciannove anni – il mio credo politico è rimasto tetro e immutato come una vecchia roccia grigia. È classico al punto da essere trito.
Freedom of speech, freedom of thought, freedom of art. The social or economic structure of the ideal state is of little concern to me. My desires are modest. Portraits of the head of the government should not exceed a postage stamp in size. No torture and no executions. No music, except coming through earphones, or played in theaters.
Why no music?
I have no ear for music, a shortcoming I deplore bitterly. When I attend a concert―which happens about once in five years―I endeavor gamely to follow the sequence and relationship of sounds but cannot keep it up for more than a few minutes. Visual impressions, reflections of hands in lacquered wood, a diligent bald spot over a fiddle, these take over, and soon I am bored beyond measure by the motions of the musicians. My knowledge of music is very slight; and I have a special reason for finding my ignorance and inability so sad, so unjust: There is a wonderful singer in my family―my own son. His great gifts, the rare beauty of his bass, and the promise of a splendid career―all this affects me deeply, and I feel a fool during a technical conversation among musicians. I am perfectly aware of the many parallels between the art forms of music and those of literature, especially in matters of structure, but what can I do if ear and brain refuse to cooperate? I have found a queer substitute for music in chess―more exactly, in the composing of chess problems.
Another substitute, surely, has been your own euphonious prose and poetry. As one of few authors who have written with eloquence in more than one language, how would you characterize the textural differences between Russian and English, in which you are regarded as equally facile?
In sheer number of words, English is far richer than Russian. This is especially noticeable in nouns and adjectives. A very bothersome feature that Russian presents is the dearth, vagueness, and clumsiness of technical terms.
Libertà di parola, libertà di pensiero, libertà dell’arte. La struttura sociale o economica dello stato ideale mi interessa poco. I miei desideri sono modesti. I ritratti dei capi di Stato non dovrebbero eccedere la grandezza di un francobollo. Niente torture né esecuzioni. Niente musica, eccetto quella che si ascolta in cuffia, o quella che si suona a teatro.
Perché niente musica?
Non ho orecchio per la musica, una lacuna che deploro amaramente. Quando assisto a un concerto – cosa che accade all’incirca una volta ogni cinque anni – mi sforzo con determinazione di seguire la sequenza e la relazione dei suoni ma non riesco a farlo per più di qualche minuto. Impressioni visive, riflessioni di mani sul legno laccato, una testa calva diligentemente curva su un violino, queste cose prendono possesso di me, e in men che non si dica sono oltremodo annoiato dai movimenti dei musicisti. La mia conoscenza della musica è molto generica; e ho una ragione speciale per considerare la mia ignoranza e la mia incapacità così tristi, così ingiuste: Nella mia famiglia C’è un meraviglioso cantante – mio figlio. Il suo grande dono, la rara bellezza della sua voce di basso, e la promessa di una splendida carriera – tutto questo mi tocca profondamente, e durante una conversazione tecnica tra musicisti mi sento un stupido. Sono perfettamente cosciente dei numerosi parallelismi esistenti tra le forme d’arte della musica e quelle della letteratura, specialmente in termini di struttura, ma cosa posso fare se orecchio e cervello si rifiutano di collaborare? Ho trovato uno strano sostituto alla musica negli scacchi – più esattamente, nella composizione dei problemi scacchistici
Un altro sostituto, per certo, è stata l’eufonia della sua prosa e poesia. Dato che è uno dei pochi autori ad aver scritto con eloquenza in più di una lingua, come descriverebbe le differenze di tessitura tra il russo e l’inglese, per le quali si ritiene che lei abbia eguale facilità?
Considerando solo il numero delle parole, l’inglese è molto più ricco del russo. Lo si può notare specialmente nei nomi e negli aggettivi. Un aspetto molto fastidioso del russo è la povertà, la vaghezza, e la goffaggine di termini tecnici.
For example, the simple phrase “to park a car” comes out―if translated back from the Russian―as “to leave an automobile standing for a long time.” Russian, at least polite Russian, is more formal than polite English. Thus, the Russian word for “sexual”―polovoy―is slightly indecent and not to be bandied around. The same applies to Russian terms rendering various anatomical and biological notions that are frequently and familiarly expressed in English conversation. On the other hand, there are words rendering certain nuances of motion and gesture and emotion in which Russian excels. Thus by changing the head of a verb, for which one may have a dozen different prefixes to choose from, one is able to make Russian express extremely fine shades of duration and intensity. English is, syntactically, an extremely flexible medium, but Russian can be given even more subtle twists and turns. Translating Russian into English is a little easier than translating English into Russian, and 10 times easier than translating English into French.
You have said you will never write another novel in Russian. Why?
During the great, and still unsung, era of Russian intellectual expatriation―roughly between 1920 and 1940―books written in Russian by émigré Russians and published by émigré firms abroad were eagerly bought or borrowed by émigré readers but were absolutely banned in Soviet Russia―as they still are (except in the case of a few dead authors such as Kuprin and Bunin, whose heavily censored works have been recently reprinted there), no matter the theme of the story or poem. An émigré novel, published, say, in Paris and sold over all free Europe, might have, in those years, a total sale of 1,000 or 2,000 copies―that would be a best seller―but every copy would also pass from hand to hand and be read by at least 20 persons, and at least 50 annually if stocked by Russian lending libraries, of which there were hundreds in West Europe alone. The era of expatriation can be said to have ended during World War II.
Per esempio, la semplice frase «parcheggiare l’automobile», diventa – se ritradotto dal russo – «lasciare un’automobile in posizione eretta per molto tempo». Il russo, almeno il russo cortese, è molto più formale dell’inglese cortese. Perciò, la parola russa per «sessuale» – polovoy – è un po’ sconcia e non va pronunciata con leggerezza. Lo stesso vale per i termini russi che traducono vari concetti anatomici e biologici che nelle conversazioni in inglese sono usati di frequente e con nonchalance. È altrettanto vero però che ci sono parole che traducono alcune sfumature di movimenti e gesti ed emozioni in cui il russo eccelle. Quindi cambiando il prefisso di un verbo, per il quale possono essercene decine tra cui scegliere, si può far sì che il russo esprima precisissime gradazioni di durata e intensità. L’inglese è, sintatticamente, un mezzo di estrema flessibilità, ma al russo si possono dare svolte inaspettate ancora più sottili. Tradurre il russo in inglese è un po’ più facile che tradurre l’inglese in russo, e dieci volte più facile che tradurre l’inglese in francese.
Lei ha detto che non scriverà mai più un romanzo in russo. Perché?
Durante la grande, e tuttora non celebrata, era dell’esilio intellettuale russo – all’incirca tra il 1920 e il 1940 – libri scritti in russo da emigrati russi e pubblicati all’estero da case editrici dell’emigrazione venivano comprati o presi in prestito con avidità da lettori emigrati ma erano assolutamente vietati nella Russia sovietica – come lo sono ancora (a parte il caso di pochi autori morti come Kuprin e Bunin, le cui opere fortemente censurate sono state di recente ristampate là), a prescindere dal tema del racconto o della poesia. Un romanzo dell’emigrazione, pubblicato, mettiamo, a Parigi e venduto in tutta l’Europa libera poteva arrivare, in quegli anni, a vendere mille o duemila copie – si sarebbe trattato di un best seller – ma ogni copia passava anche di mano in mano ed era letta da almeno venti persone da almeno cinquanta all’anno, se presente nei punti di prestito bibliotecario russi; ce n’erano a centinaia nella sola Europa occidentale. Si può dire che l’era dell’espatrio sia terminata durante la Seconda guerra mondiale.
Old writers died, Russian publishers also vanished, and worst of all, the general atmosphere of exile culture, with its splendor, and vigor, and purity, and reverberative force, dwindled to a sprinkle of Russian-language periodicals, anemic in talent and provincial in tone. Now to take my own case: It was not the financial side that really mattered; I don’t think my Russian writings ever brought me more than a few hundred dollars per year, and I am all for the ivory tower, and for writing to please one reader alone―one’s own self. But one also needs some reverberation, if not response, and a moderate multiplication of one’s self throughout a country or countries; and if there be nothing but a void around one’s desk, one would expect it to be at least a sonorous void, and not circumscribed by the walls of a padded cell. With the passing of years I grew less and less interested in Russia and more and more indifferent to the once-harrowing thought that my books would remain banned there as long as my contempt for the police state and political oppression prevented me from entertaining the vaguest thought of return. No, I will not write another novel in Russian, though I do allow myself a very few short poems now and then. I wrote my last Russian novel a quarter of a century ago. But today, in compensation, in a spirit of justice to my little American muse, I am doing something else. But perhaps I should not talk about it at this early stage.
Please do.
Well, it occurred to me one day―while I was glancing at the varicolored spines of Lolita translations into languages I do not read, such as Japanese, Finnish or Arabic―that the list of unavoidable blunders in these fifteen or twenty versions would probably make, if collected, a fatter volume than any of them. I had checked the French translation, which was basically very good yet would have bristled with unavoidable errors had I not corrected them. But what could I do with Portuguese or Hebrew or Danish? Then I imagined something else. I imagined that in some distant future somebody might produce a Russian version of Lolita.
I vecchi scrittori morirono, gli editori russi scomparvero, e la cosa peggiore fu che l’atmosfera generale della cultura dell’esilio, con il suo splendore, e il vigore, e la purezza, e la forza riverberante, si ridusse a poche riviste in lingua russa, dal talento anemico e dai toni provinciali. Adesso prendiamo il mio caso: non era l’aspetto economico che mi importava davvero, credo che i miei libri in russo non mi abbiano mai fatto guadagnare più di qualche centinaio di dollari l’anno, e io sono per la torre d’avorio al cento per cento, e per una scrittura che compiaccia un solo lettore – sé stesso. Ma abbiamo anche bisogno di un po’ di riverbero, se non di una risposta, e una moderata moltiplicazione di sé stessi attraverso un paese o più paesi; e se non ci fosse che un vuoto attorno alla propria scrivania, ci si aspetterebbe che fosse almeno un vuoto sonoro, e non circoscritto dai muri di una cella insonorizzata. Con il passare degli anni mi sono interessato sempre meno alla Russia e sono diventato sempre più indifferente al pensiero un tempo lacerante che i miei libri avrebbero continuato a essere vietati lì finché il mio disprezzo per lo stato di polizia e l’oppressione politica mi avessero impedito di contemplare anche solo vagamente l’idea di ritorno. No, non scriverò un altro romanzo in russo, nonostante in rare occasioni mi conceda qualche poesia. Ho scritto il mio ultimo romanzo in russo un quarto di secolo fa. Ma oggi, come ricompensa, in uno spirito di giustizia verso la mia piccola musa americana, sto facendo dell’altro. Ma forse, non dovrei parlarne in uno stadio così prematuro.
Lo faccia, la prego.
Beh, un giorno – mentre stavo dando un’occhiata al dorso variopinto delle traduzioni di Lolita in lingue che non comprendo, come il giapponese, il finlandese o l’arabo – mi sono reso conto che, se raccolti in un unico volume, gli inevitabili strafalcioni in quelle quindici o venti versioni probabilmente ne avrebbero costituito uno più grosso ancora. La traduzione francese l’avevo controllata, fondamentalmente era molto buona eppure se non li avessi corretti io sarebbe stata colma di errori inevitabili. Ma cosa potevo fare con il portoghese o l’ebraico o il danese? Poi ho immaginato un’altra cosa. Ho immaginato che in un futuro lontano qualcuno potrebbe produrre una versione russa di Lolita.
I trained my inner telescope upon that particular point in the distant future and I saw that every paragraph, pock-marked as it is with pitfalls, could lend itself to hideous mistranslation. In the hands of a harmful drudge, the Russian version of Lolita would be entirely degraded and botched by vulgar paraphrases or blunders. So I decided to translate it myself. Up to now I have about sixty pages ready.
Are you presently at work on any new project?
Good question, as they say on the lesser screen. I have just finished correcting the last proofs of my work on Pushkin’s Eugene Onegin―four fat little
volumes which are to appear this year in the Bollingen Series; the actual translation of the poem occupies a small section of volume one. The rest of the volume and volumes two, three and four contain copious notes on the subject. This opus owes its birth to a casual remark my wife made in 1950―in response to my disgust with rhymed paraphrases of Eugene Onegin, every line of which I had to revise for my students―”Why don’t you translate it yourself?” This is the result. It has taken some ten years of labor. The index alone runs to 5,000 cards in three long shoe boxes; you see them over there on that shelf. My translation is, of course, a literal one, a crib, a pony. And to the fidelity of transposal I have sacrificed everything: elegance, euphony, clarity, good taste, modern usage, and even grammar.
In view of these admitted flaws, are you looking forward to reading the reviews of the book?
I really don’t read reviews about myself with any special eagerness or attention unless they are masterpieces of wit and acumen―which does happen now and then. And I never reread them, though my wife collects the stuff, and though maybe I shall use a spatter of the more hilarious Lolita items to write someday a brief history of the nymphet’s tribulations.
Ho rivolto il mio telescopio interno verso quel particolare punto nel lontano futuro e ho visto che ogni paragrafo, segnato com’è da trappole, si presterebbe a ripugnanti errori di traduzione. Nelle mani di un pericoloso scribacchino, la versione russa di Lolita sarebbe del tutto umiliata e raffazzonata con parafrasi volgari o cantonate. Così ho deciso di tradurla io. Finora ho pronte circa sessanta pagine
Al momento sta lavorando a un nuovo progetto?
Bella domanda, come dicono sul piccolo schermo. Ho appena finito di correggere le ultime bozze del mio lavoro sull’Evgenij Onegin di Puškin – quattro piccoli volumotti che devono uscire quest’anno nella collana Bollingen Series; la traduzione vera e propria dell’opera occupa una piccola sezione del primo volume. Il resto del volume e i volumi due, tre e quattro contengono numerosi appunti sull’argomento. Quest’opera deve la sua nascita a un’osservazione del tutto casuale che mia moglie fece nel 1950 – in risposta al mio disgusto per le parafrasi in rima dell’Evgenij Onegin, del quale ho dovuto rivedere ogni strofa per i miei studenti – «Perché non la traduci tu?» E questo è il risultato. Ci sono voluti circa dieci anni di fatiche. Solo l’indice ammonta a cinquemila schede in tre lunghe scatole di scarpe; le vede là su quella mensola. La mia, ovviamente, è una traduzione letterale, parola per parola, un bigino. E alla fedeltà della trasposizione ho sacrificato tutto: l’eleganza, l’eufonia, la chiarezza, il buon gusto, l’uso moderno, e persino la grammatica.
In considerazione di questi che per sua stessa ammissione sono dei difetti, attende con impazienza di leggere le recensioni del libro?
Le recensioni che mi riguardano non le leggo affatto con foga né con un’attenzione particolare a meno che non si tratti di capolavori di arguzia e acume – cosa che di tanto in tanto capita. E non le rileggo mai, nonostante mia moglie conservi il tutto, e nonostante un giorno possa usare un pochino degli articoli più esilaranti su Lolita per scrivere una breve storia delle tribolazioni della ninfetta.
I remember, however, quite vividly, certain attacks by Russian émigré critics who wrote about my first novels 30 years ago; not that I was more vulnerable then, but my memory was certainly more retentive and enterprising, and I was a reviewer myself. In the nineteen-twenties I was clawed at by a certain Mochulski who could never stomach my utter indifference to organized mysticism, to religion, to the church―any church. There were other critics who could not forgive me for keeping aloof from literary “movements,” for not airing the “angoisse” that they wanted poets to feel, and for not belonging to any of those groups of poets that held sessions of common inspiration in the back rooms of Parisian cafes. There was also the amusing case of Georgiy Ivanov, a good poet but a scurrilous critic. I never met him or his literary wife Irina Odoevtsev; but one day in the late nineteen-twenties or early nineteen-thirties, at a time when I regularly reviewed books for an émigré newspaper in Berlin, she sent me from Paris a copy of a novel of hers with the wily inscription “Spasibo za Korolya, damn, valeta” (thanks for King, Queen, Knave)―which I was free to understand as “Thanks for writing that book,” but which might also provide her with the alibi: “Thanks for sending me your book,” though I never sent her anything. Her book proved to be pitifully trite, and I said so in a brief and nasty review, Ivanov retaliated with a grossly personal article about me and my stuff. The possibility of venting or distilling friendly or unfriendly feelings through the medium of literary criticism is what makes that art such a skewy one.
You have been quoted as saying: My pleasures are the most intense known to man: butterfly hunting and writing. Are they in any way comparable?
No, they belong essentially to quite different types of enjoyment. Neither is easy to describe to a person who has not experienced it, and each is so obvious to the one who has that a description would sound crude and redundant. In the case of butterfly hunting I think I can distinguish four main elements.
Ricordo, tuttavia, in modo piuttosto vivido, certi attacchi fatti da critici russi dell’emigrazione che trent’anni orsono hanno scritto a proposito dei miei primi romanzi; non che allora fossi più vulnerabile, ma la mia memoria era di certo più tenace e solerte, e io stesso ero un recensore. Negli anni Venti fui graffiato da un certo Mochulski che non riusciva a digerire la mia totale indifferenza per il misticismo organizzato, per la religione, per la chiesa – qualunque chiesa. C’erano altri critici che non mi riuscivano a perdonare che tenessi le distanze dai “movimenti” letterari, che non ostentassi l’“angoisse” che volevano vedere nei poeti, e che non appartenessi ad alcuno di quei gruppi di poeti che tenevano sessioni di ispirazione collettiva nelle salette sul retro dei caffè parigini. Ci fu anche il divertente caso di Georgij Ivanov, poeta bravo ma critico volgare. Non ho mai incontrato né lui né sua moglie, la letterata Irina Odoevcev; ma un giorno verso la fine degli anni Venti o gli inizi degli anni Trenta, in un periodo in cui recensivo regolarmente libri per un quotidiano dell’emigrazione a Berlino, lei mi mandò da Parigi una copia di uno dei suoi romanzi con la dedica enigmatica «Spazibo za Korolya, damu, valeta» (grazie per Re, regina, fante) – che ero libero di interpretare come «Grazie di aver scritto quel libro», ma che poteva anche fornirle l’alibi: «Grazie per avermi mandato il suo libro», benché non le avessi mai mandato nulla. Il suo libro si rivelò un penoso cliché, e lo dissi in una recensione breve e cattiva. Ivanov si vendicò con un articolo brutalmente personale su di me e i miei libri. La possibilità di sfogarsi o insinuare sentimenti amichevoli o poco amichevoli attraverso il mezzo della critica letteraria è quel che fa diventare quell’arte così faziosa.
Si dice che lei abbia detto: «I miei piaceri sono i più intensi noti all’uomo: andare a caccia di farfalle e scrivere. Sono in qualche modo paragonabili?
No, appartengono essenzialmente a tipi piuttosto diversi di diletto. Nessuno dei due è facile da descrivere a una persona che non l’abbia sperimentato, e ciascuno è così ovvio per chi lo ha fatto che una descrizione suonerebbe grezza e ridondante. Nel caso della caccia alle farfalle credo di poter distinguere quattro elementi principali.
First, the hope of capturing―or the actual capturing―of the first specimen of a species unknown to science: this is the dream at the back of every lepidopterist’s mind, whether he be climbing a mountain in New Guinea or crossing a bog in Maine. Secondly, there is the capture of a very rare or very local butterfly―things you have gloated over in books, in obscure scientific reviews, on the splendid plates of famous works, and that you now see on the wing, in their natural surroundings, among plants and minerals that acquire a mysterious magic through the intimate association with the rarities they produce and support, so that a given landscape lives twice: as a delightful wilderness in its own right and as the haunt of a certain butterfly or moth. Thirdly, there is the naturalist’s interest in disentangling the life histories of little-known insects, in learning about their habits and structure, and in determining their position in the scheme of classification―a scheme which can be sometimes pleasurably exploded in a dazzling display of polemical fireworks when a new discovery upsets the old scheme and confounds its obtuse champions. And fourthly, one should not ignore the element of sport, of luck, of brisk motion and robust achievement, of an ardent and arduous quest ending in the silky triangle of a folded butterfly lying on the palm of one’s hand.
What about the pleasures of writing?
They correspond exactly to the pleasures of reading, the bliss, the felicity of a phrase is shared by writer and reader: by the satisfied writer and the grateful reader, or―which is the same thing―by the artist grateful to the unknown force in his mind that has suggested a combination of images and by the artistic reader whom this combination satisfies. Every good reader has enjoyed a few good books in his life so why analyze delights that both sides know? I write mainly for artists, fellow-artists and follow-artists. However, I could never explain adequately to certain students in my literature classes, the aspects of good reading―the fact that you read an artist’s book not with your heart (the heart is a remarkably stupid reader), and not with your brain alone, but with your brain and spine.
Il primo, la speranza della cattura – o la cattura effettiva – del primo esemplare di una specie sconosciuta alla scienza: questo è il sogno nel cassetto di ogni lepidotterista, che stia scalando una montagna in Nuova Guinea o attraversando una palude nel Maine. Secondo, c’è la cattura di una farfalla molto rara o tipica di una zona – cose per cui abbiamo gongolato sui libri, su oscure riviste scientifiche, sulle splendide tavole di opere famose, e che adesso vediamo in volo, nel loro ambiente naturale, tra piante e minerali che acquistano una magia misteriosa attraverso l’intima associazione con le rarità che producono e sostengono, così che un certo paesaggio vive due volte: come affascinante zona selvaggia per le sue qualità e come luogo abituale di una certa farfalla o falena. Terzo, c’è l’interesse del naturalista nel districare le storie vitali di insetti poco conosciuti, nell’imparare le loro abitudini e la loro struttura, e nel determinare la loro posizione nello schema della classificazione – schema che a volte può essere fatto esplodere piacevolmente in un brillante spettacolo di polemici fuochi d’artificio quando una nuova scoperta scombussola un vecchio schema e confonde i suoi ottusi sostenitori. E quarto, non si dovrebbe trascurare l’elemento dello sport, della fortuna, del rapido movimento e del risultato cospicuo, di un’ardente e ardua ricerca che termina nel triangolo setoso di una farfalla piegata che giace sul palmo della propria mano.
E dei piaceri di scrivere cosa mi dice?
Corrispondono esattamente ai piaceri di leggere, la beatitudine, la felicità di una frase è condivisa dallo scrittore e dal lettore: dallo scrittore soddisfatto e dal lettore grato, o – che poi è la stessa cosa – dall’artista grato alla forza sconosciuta nella sua mente che gli ha suggerito una combinazione di immagini e dal lettore raffinato soddisfatto da questa combinazione. Ogni buon lettore ha goduto di qualche buon libro nella sua vita, perciò, perché analizzare il diletto che entrambe le parti conoscono? Scrivo principalmente per gli artisti, colleghi-artisti e seguaci-artisti. Comunque, non potrei mai spiegare in modo adeguato a certi studenti nelle mie lezioni di letteratura, gli aspetti della buona lettura – il fatto che il libro di un artista si legge non col cuore (il cuore è un lettore straordinariamente stupido) e non solo con la testa, ma con la testa e la spina dorsale.
“Ladies and gentlemen, the tingle in the spine really tells you what the author felt and wished you to feel.” I wonder if I shall ever measure again with happy hands the breadth of a lectern and plunge into my notes before the sympathetic abyss of a college audience.
What is your reaction to the mixed feelings vented by one critic in a review which characterized you as having a fine and original mind, but “not much trace of a generalizing intellect, “and as “the typical artist who distrusts ideas”?
In much the same solemn spirit, certain crusty lepidopterists have criticized my works on the classification of butterflies, accusing me of being more interested in the subspecies and the subgenus than in the genus and the family. This kind of attitude is a matter of mental temperament, I suppose. The middlebrow or the upper Philistine cannot get rid of the furtive feeling that a book, to be great, must deal in great ideas. Oh, I know the type, the dreary type! He likes a good yarn spiced with social comment; he likes to recognize his own thoughts and throes in those of the author; he wants at least one of the characters to be the author’s stooge. If American, he has a dash of Marxist blood, and if British, he is acutely and ridiculously class-conscious; he finds it so much easier to write about ideas than about words; he does not realize that perhaps the reason he does not find general ideas in a particular writer is that the particular ideas of that writer have not yet become general.
Dostoevski, who dealt with themes accepted by most readers as universal in both scope and significance, is considered one of the world’s great authors. Yet you have described him as “a cheap sensationalist, clumsy and vulgar. ” Why?
Non-Russian readers do not realize two things: that not all Russians love Dostoevski as much as Americans do, and that most of those Russians who do, venerate him as a mystic and not as an artist. He was a prophet, a claptrap journalist and a slapdash comedian. I admit that some of his scenes, some of his tremendous, farcical rows are extraordinarily amusing.
«Signore e signori, il brivido nella spina dorsale vi dice proprio che cosa l’autore ha sentito e desiderava che voi sentiste». Mi chiedo se mi capiterà ancora di misurare con mani felici la larghezza di un leggio e di tuffarmi nei miei appunti davanti all’abisso simpatetico di un pubblico di studenti.
Qual è la sua reazione verso i sentimenti contrastanti a cui ha dato sfogo un critico in una recensione che le attribuiva una mente raffinata e originale, ma «non molti indizi di un intelletto perspicace», e la descriveva come «il tipico artista che dubita delle idee»?
All’incirca con lo stesso spirito solenne, alcuni rozzi lepidotteristi hanno criticato i miei lavori sulla classificazione delle farfalle, accusandomi di essere più interessato alle sottospecie e al sottogenere che al genere e alla famiglia. Questo tipo di atteggiamento è una questione di temperamento mentale, credo. Il mediocre o il filisteo elevato non può sbarazzarsi del sentimento furtivo che un libro, per essere grande, deve trattare di idee grandi. Oh, conosco il tipo, il tipo deprimente! Gli piace un buon racconto insaporito da un commento sociale; gli piace riconoscere i suoi stessi pensieri e spasimi in quelli dell’autore; vuole che almeno uno dei personaggi sia la spalla dell’autore. Se è americano, ha un pizzico di sangue marxista, e se è britannico, ha una coscienza di classe acuta e ridicola; trova che sia molto più facile scrivere di idee piuttosto che di parole; non capisce che forse la ragione per cui non trova idee generali in un scrittore particolare è che le idee particolari di quello scrittore non sono ancora diventate generali.
Dostoevskij, che ha affrontato temi riconosciuti dalla maggior parte dei lettori come universali sia per ampiezza che per importanza, è considerato uno dei più grandi autori al mondo. Eppure lei lo ha descritto come un «un sensazionalista da quattro soldi, goffo e volgare». Perché?
I lettori non russi non capiscono due cose: che non tutti i russi amano Dostoevskij quanto gli americani, e che la maggior parte dei russi che lo ama, lo venera come mistico e non come artista. Era un profeta, un giornalista pretenzioso e un commediante sciatto. Ammetto che alcune delle sue scene, alcune delle sue tremende, farsesche risse sono straordinariamente divertenti.
But his sensitive murderers and soulful prostitutes are not to be endured for one moment―by this reader anyway.
Is it true that you have called Hemingway and Conrad “writers of books for boys”?
That’s exactly what they are. Hemingway is certainly the better of the two; he has at least a voice of his own and is responsible for that delightful, highly artistic short story, “The Killers.” And the description of the iridescent fish and rhythmic urination in his famous fish story is superb. But I cannot abide Conrad’s souvenir-shop style, bottled ships and shell necklaces of romanticist clichés. In neither of those two writers can I find anything that I would care to have written myself. In mentality and emotion, they are hopelessly juvenile, and the same can be said of some other beloved authors, the pets of the common room, the consolation and support of graduate students, such as―but some are still alive, and I hate to hurt living old boys while the dead ones are not yet buried.
What did you read when you were a boy?
Between the ages of ten and fifteen in St. Petersburg, I must have read more fiction and poetry―English, Russian and French―than in any other five-year period of my life. I relished especially the works of Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Chekhov, Tolstoy, and Alexander Blok. On another level, my heroes were the Scarlet Pimpernel, Phileas Fogg, and Sherlock Holmes. In other words, I was a perfectly normal trilingual child in a family with a large library. At a later period, in Western Europe, between the ages of 20 and 40, my favorites were Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust, and Pushkin. Of these top favorites, several―Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle, and Rupert Brooke―have lost the glamour and thrill they held for me. The others remain intact and by now are probably beyond change as far as I am concerned.
Ma i suoi assassini sensibili e le sue prostitute sentimentali non sono sopportabili nemmeno per un momento – se non altro da parte di questo lettore.
È vero che lei ha definito Hemingway e Conrad «scrittori di libri per ragazzi»?
È esattamente quello che sono. Hemingway è senza dubbio il migliore dei due: almeno ha una voce sua ed è responsabile di quel delizioso, altamente artistico racconto, Gli uccisori . E le descrizioni del pesce iridescente e dell’orinazione ritmica nella sua famosa storia di pesca sono superbe. Ma non sopporto lo stile da negozio di souvenir, navi in bottiglia e collanine di conchiglia dei cliché del romanticismo. In nessuno di quei due scrittori riesco a trovare qualcosa che vorrei aver scritto io. Per mentalità e sentimenti, sono disperatamente giovanili, e lo stesso si può dire di alcuni altri autori tanto amati, gli animali domestici delle sale d’attesa, la consolazione e il supporto degli specializzandi, come… ma alcuni sono ancora in vita, e detesto far soffrire vecchi ragazzi vivi mentre quelli morti non sono ancora stati seppelliti.
Ma lei, quando era ragazzo cosa leggeva?
Tra i dieci e i quindici anni a San Pietroburgo devo aver letto più romanzi e poesia – in inglese, russo e francese – che in qualunque altro lustro della mia vita. Apprezzavo specialmente le opere di Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Čehov, Tolstoj e Aleksandr Blok. A un altro livello, i miei eroi erano Primula Rossa , Phileas Fogg e Sherlock Holmes . In altre parole, ero un bambino trilingue perfettamente normale in una famiglia con una grande biblioteca. In un periodo successivo, nell’Europa occidentale, tra i venti e i quarant’anni, i miei preferiti erano Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust e Puškin. Di questi preferiti, molti – Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle e Rupert Brooke – hanno perso il brivido e il fascino che esercitavano su di me. Gli altri rimangono intatti e ormai per quanto mi riguarda probabilmente sono immutabili.
I was never exposed in the twenties and thirties, as so many of my coevals have been, to the poetry of the not quite first-rate Eliot and of definitely second-rate Pound. I read them late in the season, around 1945, in the guest room of an American friend’s house, and not only remained completely indifferent to them, but could not understand why anybody should bother about them. But I suppose that they preserve some sentimental value for such readers as discovered them at an earlier age than I did.
What are your reading habits today?
Usually I read several books at a time―old books, new books, fiction, nonfiction, verse, anything―and when the bedside heap of a dozen volumes or so has dwindled to two or three, which generally happens by the end of one week, I accumulate another pile. There are some varieties of fiction that I never touch―mystery stories, for instance, which I abhor, and historical novels. I also detest the so-called “powerful” novel―full of commonplace obscenities and torrents of dialogue―in fact, when I receive a new novel from a hopeful publisher―”hoping that I like the hook as much as he does”―I check first of all how much dialogue there is, and if it looks too abundant or too sustained, I shut the book with a bang and ban it from my bed.
Are there any contemporary authors you do enjoy reading?
I do have a few favorites―for example, Robbe-Grillet and Borges. How freely and gratefully one breathes in their marvelous labyrinths! I love their lucidity of thought, the purity and poetry, the mirage in the mirror.
Many critics feel that this description applies no less aptly to your own prose. To what extent do you feel that prose and poetry intermingle as art forms?
Except that I started earlier―that’s the answer to the first part of your question. As to the second: Well, poetry, of course, includes all creative writing; I have never been able to see any generic difference between poetry and artistic prose.
Tra i venti e i quarant’anni non sono mai stato esposto, come è successo a tanti miei contemporanei, alla poesia di un Eliot non proprio di prim’ordine e di un Pound decisamente di second’ordine. Li ho letti tardi, attorno al 1945, nella stanza degli ospiti a casa di un amico americano, e ne sono rimasto completamente indifferente, ma non riuscivo a capire perché qualcuno se ne dovesse curare. Ma suppongo che, per lettori che li hanno scoperti più da giovani, conservino un valore sentimentale.
Oggi quali sono le sue abitudini di lettura?
Di solito leggo molti libri alla volta – libri vecchi, libri nuovi, romanzi, saggi, poesie, qualunque cosa – e quando il mucchio di una decina di volumi sul comodino si è ridotto a due o tre, cosa che generalmente accade nell’arco di una settimana, accumulo un’altra pila. Ci sono alcuni generi di romanzi che non tocco mai – libri gialli, ad esempio, che aborro, e romanzi storici. Inoltre detesto il romanzo cosiddetto “potente” – pieno di osceni luoghi comuni e torrenti di dialoghi – infatti, quando ricevo un romanzo nuovo da un editore speranzoso – «sperando che il libro mi piaccia quanto è piaciuto a lui» controllo prima di tutto quanto dialogo c’è, e se sembra troppo abbondante o troppo sostenuto, chiudo il libro con un colpo e lo bandisco dal mio letto.
Ci sono autori contemporanei che le piace leggere?
Qualche preferito ce l’ho – per esempio, Robbe-Grillet e Borges. Con quanta libertà e gratitudine si respira nei loro labirinti meravigliosi. Amo la loro lucidità di pensiero, la purezza e la poesia, il miraggio allo specchio.
Molti critici ritengono che questa descrizione sia non meno adatta alla sua stessa prosa. A quale livello ritiene che prosa e poesia si confondano come forme d’arte?
Tranne che io ho cominciato prima – questa è la risposta alla prima parte della sua domanda. Per la seconda: beh, la poesia, di certo, comprende tutta la scrittura creativa; non sono mai riuscito a vedere nessuna differenza generica tra la poesia e la prosa artistica.
As a matter of fact, I would be inclined to define a good poem of any length as a concentrate of good prose, with or without the addition of recurrent rhythm and rhyme. The magic of prosody may improve upon what we call prose by bringing out the full flavor of meaning, but in plain prose there are also certain rhythmic patterns, the music of precise phrasing, the beat of thought rendered by recurrent peculiarities of idiom and intonation. As in today’s scientific classifications, there is a lot of overlapping in our concept of poetry and prose today. The bamboo bridge between them is the metaphor.
You have also written that poetry represents “the mysteries of the irrational perceived through rational words. ” But many feel that the “irrational” has little place in an age when the exact knowledge of science has begun to plumb the most profound mysteries of existence. Do you agree?
This appearance is very deceptive. It is a journalistic illusion. In point of fact, the greater one’s science, the deeper the sense of mystery. Moreover, I don’t believe that any science today has pierced any mystery. We, as newspaper readers, are inclined to call “science” the cleverness of an electrician or a psychiatrist’s mumbo jumbo. This, at best, is applied science, and one of the characteristics of applied science is that yesterday’s neutron or today’s truth dies tomorrow. But even in a better sense of “science”―as the study of visible and palpable nature, or the poetry of pure mathematics and pure philosophy―the situation remains as hopeless as ever. We shall never know the origin of life, or the meaning of life, or the nature of space and time, or the nature of nature, or the nature of thought.
In effetti, sarei propenso a definire una buona poesia di qualunque lunghezza un concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di un ritmo e una rima ricorrenti. L’aspetto magico della prosodia può migliorare quello che noi chiamiamo prosa tirando fuori tutto il sapore del significato, ma anche nella prosa semplice ci sono certi aspetti ritmici, la musica di un fraseggio preciso, il battere del pensiero reso da peculiarità ricorrenti di modi di dire e intonazione. Per quanto riguarda le classificazioni scientifiche odierne, oggi c’è molta sovrapposizione nel nostro concetto di poesia e prosa. Metaforicamente tra loro c’è un ponte di bambù.
Lei ha anche scritto che la poesia rappresenta «i misteri dell’irrazionale percepiti attraverso parole razionali». Ma in molti ritengono che l’«irrazionale» occupi un piccolo posto in un periodo in cui la conoscenza esatta della scienza ha cominciato a svelare i misteri più profondi dell’esistenza. È d’accordo?
Questa prospettiva è molto ingannevole. È l’illusione giornalistica. In realtà, più grande è la scienza, più profondo è il senso di mistero. Inoltre, non credo che nessuna scienza oggi abbia penetrato alcun mistero. Noi, in quanto lettori di quotidiani, siamo inclini a chiamare «scienza» l’intelligenza di un elettricista o il linguaggio incomprensibile di uno psichiatra. Questo, nella migliore delle ipotesi, è scienza applicata, e una delle caratteristiche della scienza applicata è che il neutrone di ieri o la verità di oggi muore domani. Ma persino in un senso migliore di «scienza» – come lo studio della natura visibile e palpabile, o la poesia della matematica pura e della filosofia pura – la situazione rimane disperata come sempre. Non conosceremo mai l’origine della vita, né il significato della vita, né la natura dello spazio e del tempo, né la natura della natura, né la natura del pensiero.
Man’s understanding of these mysteries is embodied in his concept of a Divine Being. As a final question, do you believe in God?
To be quite candid―and what I am going to say now is something I never said before, and I hope it provokes a salutary little chill―I know more than I can express in words, and the little I can express would not have been expressed, had I not known more.
La comprensione di questi misteri da parte dell’uomo si incarna nel concetto di Essere Divino. Come ultima domanda, lei crede in Dio?
Per essere piuttosto sinceri – e quello che sto per dire è qualcosa che non ho mai detto prima, e spero che provochi un piccolo salutare brivido – so più di quanto posso esprimere a parole, e quel poco che posso esprimere non sarebbe stato espresso, se non avessi saputo di più.
4. Postfazione
4.1. Il nudo non fa la rivista
Per chi come me ha sempre pensato a Playboy come a un magazine da sfogliare lontano da occhi indiscreti, non sarà difficile capire il mio stupore nell’apprendere che un’intervista di Mr. Nabókov fosse apparsa proprio su uno di quei giornaletti che trovano posto sugli scaffali più alti delle edicole. Decisa a trovare un nesso tra le conigliette – più o meno vestite – di Hugh Hefner e uno degli scrittori più importanti del ventesimo secolo mi è bastato svolgere una rapida ricerca su Google per scoprire che la mia idea era viziata da un grosso preconcetto: sulla copertina del numero in questione, quello di gennaio del 1964, a fare compagnia a Nabókov – quanto gradita bisognerebbe chiederlo a lui – c’erano sì delle donne nude ma anche nomi del calibro di Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Philip Roth.
4.2 Un’intervista particolare
L’intervista a Playboy è stata pubblicata nel 1973 all’interno del libro Strong Opinions, nel quale Nabókov ha raccolto ventidue interviste, undici lettere a direttori di giornali o magazine e quattordici articoli.
Una precisazione è d’obbligo, visto che quando si parla di «intervista» solitamente ci si immagina un colloquio tra un giornalista e un intervistato. Nel caso di Nabókov le cose avvenivano in modo un po’ diverso. Nessuna intervista, ad eccezione di un paio di occasioni che lui stesso ricorda divertito, si svolgeva vis–à–vis. Le domande dell’intervistatore dovevano essere messe per iscritto, consegnate a Nabókov, che rispondeva sempre per iscritto, e poi pubblicate parola per parola nell’ordine esatto in cui erano state scritte. Queste erano le tre condizioni imprescindibili.
Nella prefazione di Strong Opinions Nabókov racconta che durante le conversazioni telefoniche gli interlocutori di madrelingua inglese passavano dalla loro lingua al francese, spinti dalle sue continue pause e interiezioni; e che alle feste, nel tentativo di intrattenere gli altri ospiti con una storia, non faceva altro che tornare indietro per apportare modifiche e aggiunte a ogni frase. La conferma del fatto che avesse difficoltà a esprimersi oralmente arriva dalle sue stesse labbra, anzi, dalla sua stessa mano: «I think like a genius, I write like a distinguished author, and I speak like a child» (Nabókov 1973: XV). Per questi motivi si rifiutava di sottoporsi a interviste faccia a faccia, nonostante sapesse che gli intervistatori desideravano vedere la sua matita poggiata sul foglio, le sue mensole piene di libri o il vecchio cane addormentato ai suoi piedi per poi inserire tra una risposta l’altra qualunque dettaglio riuscissero a ricordare.
Le cose non furono diverse per Alvin Toffler, il famoso scrittore e futurologo che curò l’intervista per Playboy. Nel marzo del 1963, quando ebbe luogo questo scambio, l’autore di Lolita viveva nella suite di un hotel a Montreux, in Svizzera, già da tre anni. Fu proprio Toffler, che a quei tempi collaborava con Playboy, a proporre al direttore della rivista di intervistare Nabókov. Quando arrivò a Montreux non aveva idea di come sarebbero andate le cose, lo apprese solo in seguito, ma non ebbe altra scelta che accettare le condizioni impostegli. Toffler ha raccontato in un’intervista di aver incontrato Nabókov ogni giorno della sua permanenza a Montreux. Il giornalista si recava nella suite dello scrittore, dove i due chiacchieravano davanti a una tazza di tè per circa mezz’ora. In nessuna occasione gli fu concesso di usare il registratore. Toffler rimase a Montreux una settimana, il tempo che Nabókov impiegò per rispondere alle domande, probabilmente seduto alla scrivania o in piedi davanti al leggio nello studio.
4.3 Analisi testuale
Non è facile dare una definizione di testo saggistico perché è l’unico genere testuale caratterizzato da elementi tipici sia del genere letterario (testo narrativo, poetico, teatrale e filmico) che di quello scientifico (chiamato anche tecnico, settoriale o specifico). La tabella riportata qui di seguito (Osimo 2007: 26) può essere utile per capire quali sono le caratteristiche prese in considerazione per distinguere i generi testuali
poetico narrativo teatrale filmico saggistico scientifico
finzionalità non fiction
eleganza formale non eleganza formale
assenza di tecnicismi tecnicismi
uso libero della parola uso non libero della parola
non terminologia terminologia
tono non necessariamente serio (es. ironia) serietà del tono
obiettivo non necessariamente serio serietà dell’obiettivo
Il testo saggistico è molto diffuso sia nella stampa periodica che in quella libraria e spesso accade che l’autore del saggio sia anche autore di testi letterari (Osimo 2007: 26), proprio come in questo caso. Nabókov, com’è noto a tutti, ha scritto numerosi libri di narrativa ma anche molti saggi.
Il testo che ho tradotto è un saggio con molte caratteristiche tipiche del testo letterario: c’è un uso libero della parola, un’eleganza formale e il tono spazia dal serio all’ironico. Lo stile è personale, creativo, ricercato. Da ogni frase emergono le grandi doti di intrattenitore di Nabókov .
Bisogna sottolineare però che la precisione terminologica era per Nabókov di grande importanza, come emerge da questo frammento tratto da un’ intervista con Robert Hughes per un canale televisivo
I am now in the process of translating Lolita into Russian […] I’ve lots of difficulties with technical terms, especially with those technical terms, especially with those pertaining to the motor car, which has not really blended with Russian life as it, or rather she, has with American life. I also have trouble finding the right Russian terms for clothes, varieties of shoes, items of furniture, and so on. (Nabókov 1973: 53)
Una precisione che cercò di inculcare anche nei suoi studenti ai tempi in cui insegnava letteratura all’università
When studying Kafka’s famous story, my students had to know exactly what kind of insect Gregor turned into (it was a domed beetle, not the flat cockroach of sloppy translators) and they had to be able to describe exactly the arrangement of the rooms, with the position of doors and furniture, in the Samsa’s family flat. They had to know the map of Dublin for Ulysses. I believe in stressing the specific detail; the general ideas can take care of themselves (Nabókov 1973: 55).
4.4 Analisi traduttologica
4.4.1 Analisi linguistica
Questo saggio non è stato pubblicato su una rivista letteraria, ma essendo l’autore uno degli scrittori più importanti del ventesimo secolo, è stato scritto con la massima accortezza, ogni parola è stata scelta con estrema attenzione La posizione di un aggettivo, le ripetizioni, la sintassi, il ritmo di una frase, il suono che le parole emettono nell’essere pronunciate, ogni elemento ha un grosso peso. Questo sua attenzione per il dettaglio risulta evidente in queste poche righe, nelle quali spiega come è arrivato a scegliere il nome della sua ninfetta
mi serviva un diminutivo che avesse un’inflessione lirica. Una delle lettere più limpide e luminose è la «L». Nel suffisso «-ita» c’è molta della dolcezza latinoamericana e avevo bisogno anche di questo. Quindi: Lolita. Comunque, non dovrebbe essere pronunciato come lei e la maggior parte degli americani lo pronunciano: Low-lee-ta con una pesante e umidiccia «L» e una lunga «O». No, la prima sillaba dovrebbe essere come in «lollipop», la «L» liquida e delicata, il «lee» non troppo acuto (Nabókov 1973: 25).
Gli argomenti di questo saggio spaziano dall’esperienza dell’insegnamento alle letture preferite di Nabókov ragazzo e adulto, dalla scelta di vivere in Svizzera al rapporto con la musica, dall’arte al cinema. Alvin Toffler aveva preparato una bozza con le domande da rivolgere a Nabókov prima di incontrarlo ma come ha ammesso lui stesso sono state leggermente modificate in conseguenza di alcune risposte del suo intervistato .
Le frasi nella maggior parte dei casi sono abbastanza brevi e la sintassi è paratattica. Nella punteggiatura c’è un alto uso di incisi. Il registro è senza dubbio alto (to regard with amused contempo, execrable, deplore, acumen, splendid, dearth, opus, tribulation, coeval, forthwith), con vocaboli anche di uso letterario (changeless, limpidity), anche se non mancano abbassamenti di registro, resi da espressioni colloquiali (have I been what?, I don’t give a damn for the group) e da un lessico informale (slapdash, crank), elementi tipici del linguaggio orale. Non bisogna dimenticare che l’intenzione di Nabókov, come ha dichiarato lui stesso nel commento introduttivo all’intervista, era di «achieve the illusion of a spontaneous conversation» (Nabókov 1973: 20).
4.4.2 Analisi culturale
Il testo contiene rimandi impliciti non presenti nella cultura ricevente che in alcuni punti potrebbero rendere difficile la comprensione del testo per il lettore italiano.
Il riferimento alla Cornell University o all’anfiteatro alla Goldwin Smith, per esempio: in questi casi si è scelto di lasciare il nome intatto perché, nonostante non sia immediato per il lettore del metatesto di che tipo di istituzione si tratti, il fatto che sia un’università risulta evidente nelle righe successive.
Diverso invece è stato il caso di blue book, un realia, poiché non esiste in italiano un libricino con la copertina blu per gli studenti universitari sul quale scrivere gli esami. In questo caso si è optato per l’inserimento di una nota per spiegare cosa sono, invece di fare una traduzione letterale o di adottare una soluzione neutralizzante o localizzante.
Stesso scelta è stata fatta nel caso di C-minus, ovvero il voto che corrisponde alla sufficienza scarsa. Nel sistema scolastico americano i voti vengono assegnati in lettere mentre in quello italiano i voti sono espressi in numeri. Se da un lato “convertire” il voto avrebbe comportato un processo di localizzazione, di addomesticamento culturale che si è preferito evitare, dall’altro, non spiegare affatto cosa fosse la fraternity of C-minus lasciando così al lettore il compito di colmare la distanza culturale fra sé e il testo, avrebbe potuto portare a un equivoco, magari giungendo alla conclusione che si trattasse del nome di una confraternita.
Ovviamente ogni caso è diverso ma in linea generale molte scelte sono state prese nel tentativo di produrre una traduzione che Toury definisce «adeguata», ossia conservando il più possibile intatti gli elementi del prototesto, inserendo perciò degli esotismi nel metatesto. Sebbene questa strategia traduttiva implichi indubbiamente uno sforzo in più per il lettore di cultura italiana, gli permette tuttavia di entrare in contatto con una cultura diversa dalla propria.
Devo ammettere che nel valutare quali scelte operare durante il processo traduttivo ho tenuto in grande considerazione le opinioni di Nabókov che in più occasioni si è schierato apertamente contro la tendenza degli editori (in assenza di un editore mi sono sentita presa in causa, ricadendo tutte le decisioni su di me) a ridurre al minimo essenziale le note, ree, a loro giudizio, di interrompere la lettura che invece dovrebbe risultare il più scorrevole possibile
In primo luogo, dobbiamo accantonare una volta per tutte il concetto convenzionale secondo cui una traduzione «deve essere scorrevole» e «non deve avere l’aria di una traduzione» (per citare quelli che nelle intenzioni vorrebbero essere complimenti rivolti a versioni vaghe, da parte di eleganti redattori che non hanno mai letto né leggeranno mai i testi originali). In realtà qualsiasi traduzione che non abbia l’aria di una traduzione, a un attento esame, è destinata a risultare inesatta; mentre, d’altra parte, l’unica virtù di una buona traduzione è la fedeltà e la completezza. Se sia di scorrevole lettura o non dipende dal modello, non dall’imitatore. (Nabókov in Osimo 2004: 70)
Secondo Nabókov le note a piè di pagina sono dispositivi metatestuali utilissimi al traduttore perché gli permettono di essere più preciso, di usare una cura filologica maggiore senza per questo lasciare punti oscuri al lettore del metatesto. Il beneficio è quindi anche del lettore che raggiunge una comprensione maggiore del testo. Per tutti questi motivi le note dovrebbero addirittura superare il numero di righe del testo
È possibile descrivere in una serie di note tutte le modulazioni e le rime del testo oltre a tutte le sue associazioni e ad altre caratteristiche particolari […] Voglio traduzioni con copiose note a piè di pagina, note che salgano come grattacieli fino in cima a questa o quella pagina in modo da lasciare unicamente il barlume di una sola riga di testa tra commentario ed eternità. (Nabókov in Osimo 2004: 88)
4.4.3 Il lettore modello
Dopo aver affrontato due delle fasi del processo traduttivo, quella dell’analisi linguistica e dell’analisi culturale, a questo punto è necessario dedicarsi all’individuazione del destinatario del metatesto, ovvero il suo lettore modello che ovviamente può differire da quello del prototesto. Il traduttore, convogliando il testo a un ipotetico lettore, deve trovare «l’equilibrio ottimale tra eccesso di ridondanza e di residuo comunicativo» (Osimo 2007:10).
Per ottenere questo equilibrio bisogna considerare la cultura del lettore modello, la sua provenienza geografica, il livello d’istruzione, le esperienze fatte, in alcuni casi l’età o il sesso, o per usare le parole di Eco, la sua competenza enciclopedica.
Ancora una volta le parole di Nabókov sono state per me un ammonimento a non avere lo stesso atteggiamento degli editori che considerano il lettore meno intelligente di quanto non sia in realtà
Lo scribacchino esperto […] spiana il tono di tutto ciò che potrebbe apparire poco familiare al lettore remissivo e imbecille concepito dal suo editore. (Nabókov in Osimo 2004: 70)
Veniamo dunque a una delle scelte più importanti che il traduttore deve fare: quella del lettore modello. Il lettore modello del prototesto è una persona di cultura medio-alta in grado di cogliere le variazioni di registro (alcuni esempi sono riportati nel capitolo 4.3), di età adulta, con tutta probabilità un uomo, interessato a sapere di più della vita e delle opinioni di Nabókov. Potrebbe essere qualcuno che ha letto un suo romanzo o che ne ha sentito parlare in relazione al film Lolita, tratto dal suo romanzo. Anche il lettore modello del metatesto è una persona di cultura medio-alta, di età adulta ma non necessariamente un uomo. Qualcuno che conosce Nabókov scrittore ma sa poco di lui, che vuole scoprire alcuni suoi lati personali, oppure qualcuno che deve approfondirne la conoscenza o ottenere informazioni per motivi accademici.
4.4.4 La dominante
Nel processo di traduzione è impossibile riprodurre tutto, c’è sempre qualcosa che si perde. È compito del traduttore stabilire un ordine gerarchico tra gli aspetti del testo, partendo da quello che ritiene essenziale, la dominante, continuando con quelli meno essenziali ma comunque importanti, le sottodominanti, fino a quelli che invece deve sacrificare, il residuo traduttivo (Osimo 2007: 11).
La mia traduzione ha avuto tra i suoi obiettivi principali quello di rendere la ricchezza formale e contenutistica di questo saggio. Ho focalizzato le dominanti sia sul contenuto che sullo stile. L’efficacia del messaggio è affidata all’originalità delle scelte lessicali e sintattiche e al registro quasi sempre alto ma che in alcune occasioni subisce delle variazioni, come già sottolineato in precedenza, verso il basso. Per prima cosa dunque, ho cercato di conservare la poetica autoriale (dominante) con le sue ripetizioni, di mantenere lo stesso registro usato dall’autore ma anche di riportare opinioni, ricordi e riflessioni (dominante) inalterati. Ho prestato particolare attenzione alla peculiarità lessicale usata da Nabókov (sottodominante) e quando mi è stato possibile ho cercato di riprodurre la struttura sintattica del prototesto (sottodominante), non imponendomi di riportare la stessa costruzione delle frasi dell’inglese, ma creando una struttura standard o marcata a seconda dei casi.
Tutto le scelte sono state prese pensando a un lettore modello di cultura medio-alta.
4.4.5 Il residuo traduttivo
Nonostante Nabókov fosse russo conosceva molto bene gli Stati Uniti. Vi aveva vissuto per vent’anni, aveva ambientato lì molti dei suoi romanzi. Inoltre non va dimenticato che quest’intervista è stata pubblicata su una rivista americana. È inevitabile dunque che nel testo ci siano numerosi riferimenti alla cultura statunitense (Southwest, Cornell, full professor, blue book) che non sono di alcun disturbo per il lettore del prototesto. Ma per il lettore del metatesto la situazione è ovviamente diversa. Nel primo e nel secondo esempio qui citati ho considerato che, essendo il lettore modello di cultura medio alta, dovrebbe essere in possesso di informazioni tali da permettergli di capire da solo il riferimento. Nel terzo e nel quarto invece, dopo varie riflessioni, sono giunta alla conclusione che la mancanza di un apparato metatestuale potesse portare a un equivoco e quindi ho deciso di inserire una nota.
Vorrei sottolineare un caso di residuo traduttivo che probabilmente passerà inosservato più di altri, cioè quello di «motel». La parola è ormai da tempo entrata nell’uso comune e infatti la troviamo su qualunque dizionario
motel
s.m., invar.
Albergo per automobilisti lungo le grandi strade di comunicazione o in prossimità di queste.
A questo punto però mi vengono in mente le immagine dei motel viste in decine di film americani, con la classica insegna al neon e l’accesso alle camere direttamente davanti al parcheggio. Controllo la definizione sul monolingue d’inglese per scoprire se è una prerogativa dei motel americani
motel noun
an establishment which provides lodging and parking and in which the rooms are usually accessible from an outdoor parking area
A questo punto faccio una rapida ricerca su Google immagini e trovo ulteriore conferma alle mie supposizioni. In Italia il motel è una struttura completamente diversa, solitamente costituita da un unico edificio di più piani, e che fa pensare a giovani coppie in cerca di privacy e coppie clandestine. In questo caso la cultura del lettore italiano potrebbe fuorviarlo, ma non trovando un traducente migliore, non posso fare altro che sperare che sia un appassionato di cinema.
4.4.6 Egreto perambis doribus
Ho voluto riservare un capitolo a parte all’esclamazione «Egreto perambis doribus!» che chiude il commento introduttivo di Nabókov all’intervista.
I vaghi ricordi degli studi fatto al Liceo mi hanno fatto subito pensare che si trattasse di latino, specialmente per la parola “doribus” che aveva tutta l’aria di essere un ablativo, e così ho deciso di chiedere l’opinione di una docente di latino. Ecco la sua risposta:
«Egreto sembra simile all’imperativo futuro del verbo egredior (che vuol dire uscire), ma dovrebbe fare egredito. “Per” regge solo l’accusativo, mentre qui c’è un supposto dativo o ablativo. Ambis sembra un dativo o un ablativo ma in latino sarebbe ambobus. Perambis come parola unica non ha nessun corrispondente in latino. Doribus potrebbe essere sempre un dativo o un ablativo, ma di cosa? Solo di Dores (con la maiuscola), cioè i Dori, inteso come popolo». (Cuoghi 2009)
Escludendo che si trattasse di latino (almeno un latino corretto) ho deciso di effettuare una ricerca su internet nel tentativo di scoprire se si trattasse di un modo di dire o di una traduzione giocosa di un’esclamazione inglese. Ho riscontrato che le poche occorrenze presenti in rete si riferivano unicamente alla frase scritta da Nabókov e quindi ho capito che doveva essere un gioco di parole inventato da lui. Ho trovato elementi utili per la mia ricerca proprio in un’intervista ad Alvin Toffler nella quale Yuri Leving , il suo intervistatore, gli chiede se questa frase sia un riferimento a qualcosa di scherzoso avvenuto durante lo scambio con Nabokóv. Toffler risponde di non averla mai sentita prima ma l’interpretazione di Leving è interessante e verosimile. Si tratterebbe di una traduzione giocosa in un misto di latino/inglese della frase che negli Stati Uniti si trova sulle porte dei cinema e dei ristoranti Exit by both doors. Gli elementi che mi sono stati forniti dall’insegnante di latino supportano questa tesi: Egreto un imperativo del verbo inglese to exit, perambis potrebbe essere l’unione modificata di per e ambobus, quindi by both, e doribus potrebbe essere l’ablativo plurale di door.
Un’ultima riflessione riguarda invece la mia decisione di non mettere una nota che fornisse al lettore questa spiegazione. Per prima cosa non ho elementi per provare che la mia interpretazione sia corretta, in secondo luogo è molto probabile che chiunque legga il commento introduttivo all’intervista abbia la stessa difficoltà che ho avuto io nel cercare di dare un senso a questa esclamazione. Ma si tratta di uno scherzo, di un gioco, quindi il lettore della cultura emittente si trova nella stessa condizione di quello della cultura ricevente. Sono convinta che Nabókov si sia divertito a “sfidare” il lettore a dare una propria interpretazione e perciò ho deciso di rispettare la scelta dell’autore non aiutando il lettore italiano.
4.4.7 Alcune scelte traduttive
Vorrei dedicare questo capitolo alla spiegazione di alcune scelte traduttive da me operate nel metatesto.
La prima riguarda l’uso di you come pronome unico in inglese per la seconda persona singolare e plurale. In un testo del genere in italiano è necessario ricorrere a un pronome che si adegui a un registro medio-alto – la scelta di un confidenziale «tu» sarebbe apparsa fuori luogo al lettore italiano. Se si fosse trattato di un’intervista svoltasi in un’epoca molto lontana da quella odierna si sarebbe potuto prendere in considerazione il «voi», ma questo pronome al giorno d’oggi viene impiegato come forma di cortesia solo nel meridione. Il pronome di uso comune in italiano per rivolgersi a qualcuno con cui non si ha confidenza è «lei» e quindi ho ritenuto che questo fosse il traducente appropriato.
Nella prima domanda che rivolge a Nabókov, Alvin Toffler usa la parola cognoscenti, che nel testo è in corsivo. L’uso di questo carattere mi fa pensare che si tratti di una parola non presente nel dizionario d’inglese ma faccio comunque un tentativo. Non la trovo nel primo dizionario che consulto ma sono più fortunata al secondo tentativo
cognoscente noun
obsolete Italian (now conoscente), from cognoscente: a person who has expert knowledge in a subject: connoisseur
A questo punto consulto il dizionario d’italiano ma la parola «cognoscente» non c’è. Riesco però a trovare il verbo «cognoscere»
cognoscere
v.tr., v.intr.
OB LE var. ⇒conoscere.
Il verbo in italiano è obsoleto, di uso solo letterario, mentre in inglese non è segnalato nessun uso particolare anche se l’uso di una parola di origine italiana in inglese mi spinge a cercare un traducente di registro alto. Cerco la parola «conoscitore» sul dizionario dei sinonimi e trovo:
conoscitore
s.m.
CO Sinonimi AU esperto, specialista AD studioso CO estimatore, intenditore
Nessuno di questi sinonimi mi permetterebbe di mantenere «l’alone esotico» (Osimo 2004: 65) presente nel metatesto. Riguardo la definizione di cognoscente sul monolingue d’inglese e pensa alla possibilità di usare la parola connoisseur. Controllo il dizionario di italiano e connoisseur non c’è. A questo punto mi sembra il traducente migliore: è una parola di origine francese e quindi mi permette di mantenere nel metatesto un elemento estraneo al lettore italiano. Allo stesso tempo un lettore di cultura medio-alta non dovrebbe avere difficoltà a capirne il significato, specialmente per la familiarità della cultura italiana con i vocaboli di origine francese.
Veniamo ora a library stacks. Dal contesto penso che si tratti di scaffali usati nelle biblioteche, ma non conoscendo questo vocabolo lo cerco nel dizionario
stack noun
1: a large usually conical pile (as of hay, straw, or grain in the sheaf) left standing in the field for storage
2: a: an orderly pile or heap b: a large quantity or number
3: an English unit of measure especially for firewood that is equal to 108 cubic feet
4 a: a number of flues embodied in one structure rising above a roof b: a vertical pipe (as to carry off smoke) c: the exhaust pipe of an internal combustion engine
5 a: a structure of bookshelves for compact storage of books —usually used in plural b plural : a section of a building housing such structures
6: a pile of poker chips
7 a: a memory or a section of memory in a computer for temporary storage in which the last item stored is the first retrieved ; also : a data structure that simulates a stack b: a computer memory consisting of arrays of memory elements stacked one on top of another
Il significato che mi interessa è il quinto, si tratta effettivamente di una struttura con delle mensole, ma non sono convinta del fatto che corrispondano agli scaffali delle biblioteche usati in Italia. Consulto un’enciclopedia e scopro che gli stacks si trovano nelle stanze delle biblioteche separate dalle sale di consultazione. Penso alla possibilità di usare «scaffalatura» la cui definizione è
scaffalatura
s.f.
Serie di scaffali disposti in modo da costituire un unico insieme e da rivestire parzialmente o totalmente le pareti un ambiente
Faccio una ricerca sul dizionario dei sinonimi, ma non trovo niente che mi possa essere utile. Anche la ricerca in internet non mi porta da nessuna parte. Purtroppo non riesco a trovare una parola che si riferisca a una struttura usata esclusivamente nelle stanze delle biblioteche e quindi, consapevole di creare un residuo, decido comunque di usare «scaffalatura». L’unica alternativa sarebbe stata di mantenere stacks mettendo una nota ma dopo alcune riflessioni arrivo alla conclusione che «scaffalatura» sia comunque un buon compromesso tra scorrevolezza e residuo.
Una parola che mi ha causato diversi problemi è stata émigré. Nel testo compare sei volte: émigré Russians, émigré firms, émigré readers, émigré novel, émigré critics, émigré newspaper. Cerco la parola sul dizionario
émigré noun
emigrant ; especially : a person who emigrates for political reasons
Si tratta dunque di un sostantivo che qui è usato come apposizione. Controllo la parola emigrante sul dizionario d’italiano
emigrante
s.m. e f.
Chi si trasferisce all’estero (o in regione diversa dalla propria), generalmente in cerca di lavoro e per migliorare la propria posizione economica.
Nella definizione non c’è alcun riferimento a un allontanamento dalla patria per ragioni politiche. Cerco «emigrante» sul dizionario dei sinonimi
emigrante
CO emigrato; AU (per motivi politici) profugo
«Profugo» sembra avvicinarsi al significato di émigré e così consulto il dizionario d’italiano
profugo
agg. e s.m.
Costretto ad abbandonare la propria terra, il proprio paese, la patria, in seguito a eventi bellici, a persecuzioni, oppure a cataclismi.
Questa definizione indubbiamente si avvicina a quella di émigré. Ma la mia intenzione sarebbe di riuscire a mantenere la ripetizione in tutti i sei casi e quindi faccio un tentativo: profughi russi, case editrici profughe, lettori profughi, romanzo profugo, critici profughi, quotidiano profugo. La scelta di profugo si adatterebbe solo al primo caso. Decido di ricorrere all’uso della rete e faccio un tentativo associando questi sostantivi alla parola «emigrazione». Scopro che c’è un numero di occorrenze abbastanza alto di «letteratura dell’emigrazione», «romanzo dell’emigrazione», «quotidiano dell’emigrazione». A questo punto sono soddisfatta e decido di utilizzarlo in quattro dei casi presi in esame «case editrici dell’emigrazione», «romanzo dell’emigrazione», «critici russi dell’emigrazione» e «quotidiano dell’emigrazione». Negli altri due casi opto per «emigrati» che ha la stessa radice di emigrazione, mantenendo così una seppur parziale ripetizione.
Vorrei dedicare quest’ultimo paragrafo all’aspetto grafico della mia traduzione. Ho cercato di apportare meno cambiamenti possibili, rispettando ovviamente le norme redazionali in italiano. Così è stato mantenuto il corsivo per le domande e il tondo per le risposte. Per quanto riguarda la punteggiatura ho conservato la scansione delle frasi del prototesto rispettando tutti i punti, mentre ho spostato o aggiunto delle virgole laddove il ritmo della frase in italiano lo richiedeva. L’alto uso dell’inciso presente centosette volte nel testo inglese è stato mantenuto in tutte le occasioni, sostituendo il trattino lungo ( ― ) tipico del saggio inglese, con quello medio ( – ) secondo le norme redazionali italiane.
Riferimenti bibliografici
CUOGHI S. 2009 corrispondenza privata
DEVOTO G. – OLI G.C. 2009 Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier, Milano, ISBN 8804578185
DE MAURO T. 2000 Il dizionario della lingua italiana, Paravia, Torino, ISBN 8839550267
MERRIAM-WEBSTER The Merriam-Webster Dictionary, Springfield, Merriam-Webster Incorporated, 2004, ISBN 087779930X.
LEVING Y. Lost in transit, Nabokov Online Journal, Vol. III 2009. Disponibile in internet all’indirizzo: http://etc.dal.ca/noj/volume3/articles/02_AToffler.pdf. Consultato nel maggio 2009.
NABÓKOV V. Problems of translation: Onegin in English, in Partisan Review, n. 22, 1955.
NABÓKOV V. Foreword, in Lermontov, M. A Hero of Our Time, traduzione di V. Nabókov 1958. Oxford, Oxford University Press, 1984, ISBN 0-19-281401-X.
OSIMO B. La traduzione saggistica dall’inglese. Guida pratica con versioni guidate e glossario. Milano, Hoepli, 2007, ISBN 88-203-3741-X.
OSIMO B. Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario. Seconda edizione. Milano, Hoepli, 2004, ISBN 88-203-3269-8.
OSIMO B. Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con tavole sinottiche. Milano, Hoepli, 2001, ISBN 88-203-2935-2.
OSIMO B. Traduzione e qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale. Milano, Hoepli, 2004, ISBN 88-203-3386-4.
The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. New York, Columbia University Press, 2001–07. Disponibile in internet all’indirizzo: http://www.bartleby.com/65/
Consultato nel maggio 2009